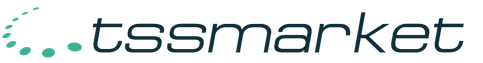Semiotica come scienza e disciplina. L'origine della semiotica. (18 punti)
SCUOLE SEMIOTICHE E DIREZIONI La semiotica è una scienza che studia la struttura e il funzionamento dei sistemi di segni.
L'idea di creare una scienza dei segni è nata quasi simultaneamente e indipendentemente da diversi scienziati. Il logico, filosofo e naturalista americano Charles Pearce (1839-1914) è considerato il fondatore della semiotica, che ne suggerì il nome. Peirce ha dato una definizione di segno, una prima classificazione dei segni (indici, icone, simboli), ha stabilito i compiti e la struttura della nuova scienza.
Un po 'più tardi, il linguista svizzero F. de Saussure (1857-1913) formulò i fondamenti della semiologia, o scienza dei segni. Il famoso Corso di Linguistica Generale (un corso di lezioni) fu pubblicato dai suoi studenti dopo la morte dello scienziato nel 1916. Il termine "semiologia" è ancora usato in alcune tradizioni (principalmente francese) come sinonimo di semiotica.
Scuole e direzioni della semiotica nella seconda metà del XX secolo. può essere determinato dall'oggetto di ricerca dominante, dalle caratteristiche territoriali (spesso unendo i sostenitori di un metodo) e dal credo teorico dei ricercatori di una scuola. Possiamo parlare delle seguenti tendenze semiotiche relativamente autonome: la scuola francese di semiotica e strutturalismo; regia semiotica Umberto Eco; Scuola semiotica di Tartu; Scuola semiotica di Mosca; Scuola semiotica polacca; Scuola dell'Università della Ruhr a Bochum; opere semiotiche di scienziati russi non unite in gruppi e direzioni.
All'inizio degli anni '60 si era formato a Mosca un gruppo di ricercatori che si avvicinarono alla semiotica in modi diversi: dalla linguistica strutturale e dalla traduzione automatica, dagli studi comparativi e dalla linguistica generale. Alcuni di loro divennero dipendenti del settore della tipologia strutturale dell'Istituto di studi slavi dell'Accademia delle scienze dell'URSS, guidato da V.N. Toporov dal 1960 al 1963, e V.V. Ivanov dal 1963 al 1989. Furono loro a diventare gli ideologi di quel ramo semiotico, che in seguito ricevette il nome di Scuola semiotica di Mosca. Questo gruppo comprendeva dipendenti del settore: A.A. Zaliznyak, I.I. Revzin, T.N. Moloshnaya, T.M. Nikolaeva, T.V. Tsivyan, Z.M. Volotskaya e altri.
Dal punto di vista della semiotica, la principale unità strutturale del linguaggio della cultura sono i sistemi di segni.
La semiotica è divisa in tre aree principali: sintattica (o sintassi), semantica e pragmatica. La sintattica studia la relazione tra i segni e le loro componenti (si tratta principalmente di significanti). La semantica studia la relazione tra significante e significato. La pragmatica studia la relazione tra un segno e i suoi utenti.
Oggetto e compiti della semiotica. Il posto della semiotica nel cerchio delle altre scienze. (18 punti)
Il soggetto della semiotica è qualsiasi sistema di segni. La semiotica si basa sul concetto di segno, inteso in modi diversi nelle diverse tradizioni. Nella tradizione logico-filosofica risalente a C. Morris e R. Carnap, un segno è inteso come una sorta di vettore materiale che rappresenta un'altra entità (in un caso particolare, ma più importante, l'informazione). Nella tradizione linguistica, che risale a F. de Saussure e alle opere successive di L. Elm - a sinistra, un segno è un'entità bilaterale. In questo caso, seguendo Saussure, il vettore materiale è chiamato significante, e ciò che rappresenta è il segno significato. I sinonimi per "significante" sono i termini "forma" e "piano di espressione", e i termini "contenuto", "piano di contenuto", "significato" e talvolta "significato" sono usati anche come sinonimi per "significato".
Nella vita di tutti gli esseri viventi - sia umani che animali - i segni sono di grande importanza, tutta l'attività umana e molte forme di comportamento animale sono basati su di essi. Ecco perché molte scienze si occupano di segni: linguistica, psicologia, matematica, cibernetica, ecc.
E la funzione significativa della pubblicità nel mondo moderno è associata alla creazione di attività pubblicitarie efficaci e al suo impatto sul consumatore. Allo stesso tempo, nessuna delle aree precedenti e altre copre il problema generale e integrale del segno nell'astrazione dalle sue proprietà specifiche inerenti a questa scienza.
L'ultimo compito - lo studio del segno in quanto tale - è proprio l'attività della semiotica. La semiotica definisce un segno come tale, classifica i segni, li raggruppa secondo determinati criteri, fornisce situazioni di segno e casi di utilizzo di segni. Ma tutto questo diventa possibile solo perché la semiotica possiede conoscenze di scienze particolari, concrete, in cui vengono descritte specifiche situazioni di segno e metodi specifici di utilizzo dei segni. I dati delle singole scienze speciali sono la base per l'applicazione della semiotica. Ma, combinando tutti i dati delle singole scienze, la semiotica deduce e formula disposizioni generali e leggi relative ai segni.
In ambito umanistico, la semiotica ha principalmente un significato metodologico e strumentale: è un sistema di concetti e principi di ricerca che hanno dimostrato la loro efficacia nello studio dei vari processi informativi e delle loro realizzazioni di segni. La semiotica non ha un oggetto che non sarebbe considerato in altri campi della conoscenza. La specificità della semiotica non è in un'area tematica di interesse speciale, ma in una visione speciale, vale a dire semiotica, degli oggetti di diverse discipline umanistiche.
Teoria e modelli.
Charles Sanders Pierce (1837-1914) era un logico; il suo lavoro sulla semiotica divenne noto già negli anni '30. Peirce appartiene alla divisione dei segni semiotici in indici (segni che puntano direttamente a un oggetto), icone o segni iconici (segni con un piano di espressione simile al fenomeno della realtà rappresentata) e simboli (segni con un piano di espressione che non è correlato all'oggetto designato). Peirce ha distinto tra estensionale, i.e. l'ampiezza di copertura del concetto (l'insieme di oggetti a cui questo concetto è applicabile) e l'intenzione, ad es. la profondità del contenuto del concetto.
Il destino di Ferdinand de Saussure (1857-1913) è simile a quello di Pierce: entrambi vissero nello stesso periodo, le loro opere furono riconosciute dopo la morte. Una delle disposizioni principali della teoria semiotica di Saussure è l'interpretazione del segno come entità mentale bilaterale: concetto + immagine acustica. Un segno diventa tale quando occupa un certo posto nel sistema delle opposizioni. La seconda posizione importante in questa teoria è l'idea di arbitrarietà, o non motivazione, di un segno linguistico (il che significa che non esiste una connessione naturale tra il concetto e l'aspetto acustico della parola che lo denota, che è dimostrato dal fatto stesso dell'esistenza lingue differentichiamando le stesse cose in modo diverso). Saussure introdusse nella semiotica (che chiamò "semiologia") la distinzione tra sincronicità e diacronia, la distinzione tra langue (linguaggio come sistema) e parole (attività linguistica). Fondamentale e “slogan” per molte generazioni è stata la tesi di de Saussure sull'esistenza autonoma del linguaggio: “l'unico e vero oggetto della linguistica è il linguaggio considerato in sé e per sé”.
Charles William Morris (1901-1978) ha incluso la semiotica nell'enciclopedia della conoscenza nel 1938. Riconoscendo che una caratteristica dell'intelligenza umana è la generazione di segni, Morris afferma che la semiotica è progettata per risolvere il problema dell'unificazione delle scienze. Distingue la semiotica come un insieme di segni (e la loro scienza) e il processo in cui qualcosa funziona come un segno: il processo della semiosi. Morris possiede la suddivisione ormai generalmente accettata delle dimensioni della semiosi nella relazione dei segni con i loro oggetti (semantica), nella relazione dei segni con i loro utenti, o interpreti (pragmatica), e nella relazione dei segni tra loro (sintassi ).
Il modello di Roman Yakobson
Negli anni post-rivoluzionari si trasferisce a Praga e poi negli Stati Uniti, dove lavora come professore al Massachusetts Institute of Technology. Nella sua opera "Linguistica e poetica", ha presentato la comunicazione vocale sotto forma dei seguenti sei fattori, ciascuno dei quali corrisponde a una funzione speciale della lingua:
La funzione emotiva (espressiva) è associata al destinatario e mira a esprimere il suo atteggiamento nei confronti di ciò che dice. In una lingua, di regola, possiamo disporre lo stesso contenuto anche intonazionalmente in modo che la nostra approvazione, condanna, ecc. Sia chiara. R. Yakobson fa un esempio in cui un attore del Moscow Art Theatre, come esperimento, ha pronunciato la frase "Tonight" usando quaranta intonazioni diverse. E, cosa più importante, queste intonazioni sono state lette chiaramente dal pubblico.
La funzione conativa è il vocativo e l'imperativo. Esprime un impatto diretto sull'interlocutore.
Funzione fatina Sono conversazioni sul tempo, conversazioni durante la celebrazione di un compleanno, dove la cosa più importante non è la novità delle informazioni, ma il processo di mantenimento del contatto. Spesso controlliamo il contatto con le parole "Stai ascoltando?"
La funzione metalinguaggio è legata al codice: senza conoscere una parola, possiamo chiedere il suo significato e ottenere una risposta. La risposta può essere data in modo descrittivo, utilizzando altre parole o semplicemente mostrando l'oggetto.
La funzione poetica è orientata al messaggio. Questa è una funzione centrale per l'arte verbale, che è caratterizzata da una maggiore attenzione alla forma che al contenuto del messaggio. Il nostro discorso quotidiano è più orientato al contenuto.
La funzione referenziale (denotativa, cognitiva) è orientata al contesto ed è un riferimento all'oggetto in questione nel messaggio.
R. Jacobson ha sostanzialmente integrato e sviluppato la divisione dei segni in tipi proposta da C. Peirce. Se i segni di Peirce - icone, indici e simboli - stanno separatamente l'uno dall'altro, allora Jacobson credeva che tutti i segni abbiano caratteristiche comuni, la differenza sta nella predominanza di una caratteristica sulle altre.
Il modello di Yuri Lotman
Yuri Lotman si è guadagnato il riconoscimento dei suoi contemporanei durante la sua vita e dopo la sua morte il presidente estone ha affermato che l'Estonia è conosciuta nel mondo come il paese in cui ha lavorato il professor Lotman. Ciò è dovuto al fatto che quasi tutte le opere di Yuri Lotman sono state tradotte e pubblicate in diverse lingue. In epoca sovietica, Yu Lotman era il meccanismo propulsore della scuola semiotica di Tartu-Mosca, la cui formazione fu aiutata dai lavori sulla semiotica pubblicati a Tartu e dalle conferenze tenute lì.
Yu Lotman credeva che in realtà chi parla e chi ascolta non possano avere esattamente gli stessi codici, così come non può esserci la stessa quantità di memoria. "La lingua è un codice più la sua storia," corresse Yuri Lotman R. Yakobson. Con una completa somiglianza tra chi parla e chi ascolta, il bisogno di comunicazione in generale scompare: non avranno nulla di cui parlare. L'unica cosa che rimane è la trasmissione dei comandi. Cioè, la comunicazione richiede inizialmente la non equivalenza di chi parla e chi ascolta.
Yu Lotman parla della comunicazione stessa come della traduzione di un testo dalla lingua del mio "io" nella lingua del tuo "tu". "La possibilità stessa di una tale traduzione è dovuta al fatto che i codici di entrambi i partecipanti alla comunicazione, sebbene non identici, formano insiemi intersecanti".
Il fenomeno della lettura di un testo già noto porta Yu Lotman a formulare due possibili tipologie di acquisizione di informazioni. Ad esempio, una nota e una sciarpa con un nodo. Se nel primo caso il messaggio è racchiuso nel testo e da lì può essere rimosso, nel secondo caso il messaggio non può essere estratto dal testo, che svolge un ruolo puramente mnemonico.
"Possiamo considerare due casi di aumento delle informazioni di proprietà di qualsiasi individuo o collettivo. Uno sta ricevendo dall'esterno. In questo caso, le informazioni vengono generate da qualche parte sul lato e in un volume costante vengono trasmesse al destinatario. Il secondo è costruito in modo diverso : solo una certa parte dell'informazione viene ricevuta dall'esterno., che svolge il ruolo di agente causale, provocando un aumento delle informazioni all'interno della coscienza del destinatario. "
Così leggeva una persona del passato, che poteva avere un solo libro, ma una lettura che poteva comunque arricchirlo di nuove conoscenze. Un uomo moderno, leggendo un libro uno dopo l'altro, li "piega" meccanicamente nella memoria.
Modello Umberto Eco
Il semiotico italiano Umberto Eco è noto anche per i suoi romanzi bestseller, tra i quali il romanzo Il nome della rosa ha ricevuto il massimo riconoscimento.
U. Eco ha fatto un'osservazione importante sul ruolo che definisce abitualmente la linguistica nell'analisi semiotica: "non tutti i fenomeni comunicativi possono essere spiegati con l'aiuto di categorie linguistiche". Questa osservazione lo allontana dalla scuola Tartu-Mosca, nella cui struttura era intuitivamente riconosciuta la natura fondamentale della linguistica.
Allo stesso tempo, U. Eco nomina i punti di origine delle bugie come l'oggetto più interessante per la semiotica. E questo ci riporta chiaramente al linguaggio naturale. Sebbene, dal punto di vista della norma, sia la letteratura che l'arte dovrebbero essere riconosciute come una menzogna, poiché descrivono qualcosa che non è mai accaduto. E questi sono gli oggetti più familiari per l'analisi semiotica.
U. Eco interpreta il segno iconico come un continuum in cui è impossibile isolare elementi semantici discreti simili a quelli esistenti nel linguaggio naturale. U. Eco inserisce questa nota osservazione in un sistema che spiega la differenza nella comunicazione visiva.
"I segni del disegno non sono unità di divisione, significano solo nel contesto (un punto inscritto in una forma a mandorla, che significa una pupilla) e non significano da soli, non formano un sistema di rigide distinzioni, all'interno del quale un punto acquista il suo significato, essendo opposto a una linea retta o cerchio. "
Nel linguaggio naturale, il significato è predeterminato; nel linguaggio visivo, viene generato quando il messaggio viene ricevuto.
Un segno iconico che assomiglia all'oggetto raffigurato non assume tutte le sue caratteristiche. un esempio del genere: un artista del XIII secolo disegna un leone secondo i requisiti dei codici allora iconici, e non in base alla realtà. Un segno visivo deve avere i seguenti tipi di caratteristiche: a) ottica (visibile), b) ontologica (presunta), c) convenzionale. U. Eco intende questi ultimi come i codici iconografici di quel tempo.
U. Eco offre il seguente modello di comunicazione
Si tratta di un modello applicato standard, rafforzato dal concetto di lessicodi o codici secondari, con cui U. Eco comprende vari significati connotativi aggiuntivi che non sono noti a tutti, ma solo a una parte dell'audience.
Analizzando il cristianesimo primitivo, U. Eco ha sottolineato che per influenzare era necessario inventare parabole e simboli, cosa che una teoria pura non può fare. Gesù, ad esempio, era simboleggiato dall'immagine di un pesce.
Il professor Umberto Eco ha dedicato uno studio a parte sulla comunicazione all'interno della cultura di massa. Il suo postulato principale è che quando si considerano i testi della cultura di massa, sono scritti simultaneamente sia dall'autore che dal lettore. Analizza allo stesso tempo superman, i romanzi di spionaggio di J. Fleming, "Parisian Mysteries" di Eugene Hsiu. Nasce anche qui l'idea della letteratura come collage, come kitsch.
L'atto comunicativo e la sua struttura. La prosemica come scienza dello spazio comunicativo. (18 punti)
Nella linguistica moderna, il termine "atto comunicativo" è inteso in modo abbastanza ampio: dallo scambio di testi orali o presentati per iscritto, a una situazione di ruolo in cui i ruoli sono regolati dall'ambiente sociale e nazionale-culturale, che regola la gerarchia dei motivi e dei significati personali dei comunicanti con l'ausilio di stereotipi linguistici e non linguistici ...
La prosemica è la scienza dello spazio comunicativo; è la scienza di come una persona pensa a uno spazio comunicativo, di come ci si abitua e lo usa. L'argomento della prossemica è la concettualizzazione non verbale e l'organizzazione culturale dello spazio, lo studio dei modi di percezione, organizzazione e uso dello spazio da parte delle persone durante la comunicazione.
Concetto di segno. Componenti del segno. Forma, significato, sintattica e pragmatica del segno. (18 punti)
Un segno è un oggetto materiale (fenomeno, evento) che sostituisce oggettivamente qualche altro oggetto, proprietà o relazione e viene utilizzato per acquisire, memorizzare, elaborare e trasmettere messaggi (informazioni, conoscenza). Esistono sei tipi di segni e sistemi di segni: naturali, funzionali, iconici, convenzionali, verbali, sistemi di registrazione.
Familiare naturale significa cose e fenomeni naturali nel caso in cui indicano alcuni altri oggetti o fenomeni e sono considerati come portatori di informazioni su di essi. I segni naturali sono segni-segni, ad esempio il fumo è un segno di fuoco. Per comprendere i segni naturali, è necessario sapere di cosa sono un segno ed essere in grado di estrarre le informazioni che contengono.
La SEMIOSI è il processo di generazione e funzionamento dei segni. Questo termine è stato usato per la prima volta, a quanto pare, greco. il dottor Galen da Pergamo (139-199 gg. dC), che ha chiamato S. interpretazione dei sintomi della malattia. Gli autori antichi includevano tre componenti in S .; 1) cosa fa da segno; 2) cosa indica il segno; 3) l'impatto che il segno ha su una persona (cioè il modo di interpretare).
La sintattica studia le leggi oggettive della struttura dei sistemi di segni.
Il suo compito è descrivere lo stock di testi correttamente costruiti (caratteri composti) per varie classi di sistemi di segni. Idealmente, dovrebbe descrivere tutti i testi validi.
La semantica studia le leggi del significato.
Il concetto centrale della semantica è il concetto di significato o senso. Di solito, per chiarire la struttura del significato linguistico, viene utilizzato un "quadrato semantico": segno (parola) - denotatum (oggetto) - concetto. Nel significato della parola, un certo oggetto, un "frammento" di realtà, trova il suo riflesso generalizzato: la parola è il nome non di un oggetto separato, ma di un'intera classe di oggetti. Oggetti e fenomeni della realtà si riflettono nella coscienza umana sotto forma di concetti logici. Quindi, il significato è la correlazione di un segno (parola) con un certo concetto.
Nel triangolo semantico, le componenti obbligatorie sono "segno" e "concetto" e "denotazione" può essere assente.
Ad esempio, tutte le persone conoscono vari personaggi delle fiabe: Babu Yaga, Koshchei l'Immortale, Cappuccetto Rosso, ecc. - e possono descriverli approssimativamente e dare loro alcune caratteristiche. Di conseguenza, il segno e il concetto esistono. Ma la denotazione - il personaggio stesso - non esiste.
La pragmatica è una sezione di semiotica dedicata alla considerazione e allo studio del rapporto dei soggetti che percepiscono e utilizzano un qualsiasi sistema di segni (i suoi "interpreti") con il sistema di segni stesso.
Charles Peirce è considerato il fondatore della pragmatica, ulteriori contributi significativi sono stati fatti da Ch. Morris (che possiede il termine "pragmatica") e altri scienziati.
la pragmatica studia le proprietà e le relazioni di qualsiasi sistema di segni con i mezzi ineffabili di questo sistema di segni stesso.
Quando si spiega il concetto di "pragmatica", un sistema di segnalazione del traffico - un semaforo - è spesso citato come l'esempio più semplice di un sistema di segnaletica. Questo sistema ha tre segni: rosso per "stop", verde per "può andare" e giallo per "prepararsi a muoversi (o fermarsi)".
Tipi di segni. I principali contrasti nel sistema dei segni. Classificazioni dei segni. (leggi sulla semiotica) (18 punti)
I segni naturali sono intesi come cose e fenomeni naturali nel caso in cui indicano altri oggetti o fenomeni e sono considerati portatori di informazioni su di essi. I segni naturali sono segni-segni, ad esempio il fumo è un segno di fuoco. Per comprendere i segni naturali, è necessario sapere di cosa sono un segno ed essere in grado di estrarre le informazioni che contengono.
I segni funzionali sono cose e fenomeni che hanno uno scopo pragmatico diretto e diventano segni perché sono inclusi nell'attività umana e trasportano informazioni su di essa. Questi sono anche segni-segni, ad esempio apparecchiature industriali, poiché qualsiasi meccanismo o dettaglio può fungere da segno contenente informazioni sull'intero sistema tecnico, di cui è un elemento, ad esempio, le azioni di un insegnante che fa scorrere il dito un elenco di studenti in un diario, diventa un segno di un sondaggio iniziale. I segni funzionali hanno spesso significati secondari attribuiti loro per analogia, il che è particolarmente evidente nelle superstizioni: un ferro di cavallo - fortunatamente una donna con i secchi vuoti - purtroppo, ecc.
I segni iconici sono segni-immagini, il cui aspetto riflette l'aspetto delle cose che designano. Di norma, vengono creati artificialmente, sebbene occasionalmente possano essere utilizzati oggetti naturali se sono simili all'oggetto che vogliono designare. Quindi, nella musica, i tuoni, le onde del mare, ecc. Vengono imitati; in questo caso, i segni sono simili agli oggetti designati nel materiale. Le immagini artistiche create da scrittori, pittori o scultori descrivono persone, animali o eventi in modo molto accurato, sebbene siano più o meno arbitrarie.
I segni convenzionali (convenzionali) sono segni creati artificialmente a cui le persone hanno accettato di assegnare un certo significato. Potrebbero non somigliare affatto all'oggetto che rappresentano (sebbene ciò non sia escluso), ad esempio, una campana di scuola. una croce rossa su un'ambulanza, un passaggio pedonale su un passaggio pedonale, ecc. Esistono tre tipi principali di segnali convenzionali: segnali, indici e simboli.
Segnali: segnali di avviso o di avvertimento, come i colori dei semafori.
Gli indici sono simboli di oggetti o situazioni che hanno una forma compatta e vengono utilizzati per distinguere questi oggetti e situazioni da una serie di altri. A volte (ma non necessariamente) cercano di selezionarli in modo che il loro aspetto suggerisca cosa significano, ad esempio, letture di strumenti, icone convenzionali nei diagrammi, nei grafici, ecc.
I simboli sono segni che non solo indicano un oggetto, ma portano anche un significato aggiuntivo. Se i significati di altri segni si riferiscono a cose e oggetti del mondo fisico reale, oa fenomeni di vita mentale e spirituale, allora i significati dei simboli indicano il significato, il valore di questi fenomeni sia per una singola persona, sia per piccoli e grandi gruppi di persone, popoli, stati, l'umanità nel suo insieme. Esempi di simboli sono emblemi di stato, bandiere, inni - segni simbolici della dignità degli stati.
Il concetto di processo di segno (semiosi). Tipi di semiosi. (18 punti)
La SEMIOSI è il processo di generazione e funzionamento dei segni. Introdotto da morris
Un caso speciale di semiosi è la comunicazione vocale (o atto linguistico) e un caso speciale di un codice è il linguaggio naturale. Quindi il mittente è chiamato l'oratore, il destinatario è chiamato l'ascoltatore, o anche il destinatario, ei segni sono chiamati segni linguistici. Il codice (e anche il linguaggio) è un sistema che include la struttura dei segni e le regole per il suo funzionamento.
Ciascuno dei partecipanti a qualsiasi comunicazione di segno molto spesso partecipa in ogni momento con una sola metà della propria: o riproduce i segni o li percepisce. Di conseguenza, è consigliabile individuare due particolari tipi di semiosi, in ciascuno dei quali partecipano diverse metà degli interpreti (partecipanti alla comunicazione).
Significato (semiotica) come trasformazione di una cosa in segno. Segni nella vita, nella cultura e nella lingua. (18 punti)
SIGNIFICATO è un concetto di base che fissa la proceduralità di un testo acquisendo un significato che inizialmente non è né dato né dato.
La differenza fondamentale tra un simbolo e un mito sta nel fatto che un mito è sempre una trama, è sempre una sorta di disegno esterno del concetto di essere. Il simbolo è sovra-trama e molto più sfocato, vago, ma può assorbire trame.
La creazione del mito è possibile oggi, ma solo come un gioco dell'immaginazione, e non come una realtà assoluta, il mito è arcaico, il simbolo funziona ancora nella nostra cultura, il simbolo è il rinnovamento del mito a livello moderno dello stato della civiltà.
Combinazione di segni in sistemi. Il concetto di sistema semiotico. La struttura interna del sistema di segnaletica. (18 punti)
Le relazioni che esistono tra i segni in un sistema di segni sono chiamate paradigmatiche. Tra le relazioni paradigmatiche più importanti ci sono la sinonimia, l'omonimia, ecc.
Insieme alle relazioni paradigmatiche tra i segni, esiste un altro tipo di relazione: sintagmatica. Le relazioni tra i segni che sorgono nel processo della loro combinazione sono chiamate sintagmatiche. Sono le relazioni sintagmatiche che garantiscono l'esistenza del testo - il risultato dell'azione del sistema dei segni nel processo di comunicazione.
Relazioni paradigmatiche (relazioni in un sistema di segni). I principali tipi di relazioni paradigmatiche. (18 punti)
I segni che compongono il sistema linguistico entrano in rapporti di due tipi tra loro. Queste sono relazioni di contiguità, successione, compatibilità - relazioni sintagmatiche. O relazioni di somiglianza, intercambiabilità, opposizione - relazioni paradigmatiche.
La distinzione è fatta per opposizione paradigmatica (per somiglianza o differenza di contenuto) o per contrasto sintagmatico in una serie lineare, se compatibili. In una riga lineare e più spesso entrambi insieme. Confrontare: la casa è in fase di ristrutturazione (edificio), mantenere pulita la casa (abitazione), amici di casa, proprietario della casa (famiglia), trovare una casa (casa), tutta la casa a parlare (residenti della casa).
Le relazioni paradigmatiche e sintagmatiche tra le parole possono essere rappresentate come due assi intersecanti: orizzontale (compatibilità) e verticale (somiglianza semantica):
Le relazioni sintagmatiche e paradigmatiche sono le categorie di linguaggio più ampie e complete. Tutti gli altri tipi di relazioni tra le unità sono sussunti sotto di loro, quindi sinonimia e antonimia, declinazione di un sostantivo, cambio di un aggettivo per genere sono un caso speciale di relazioni paradigmatiche e il coordinamento di un aggettivo e un sostantivo è l'implementazione di connessioni sintagmatiche. Ogni parola in una persona che parla la lingua causa un'intera catena di connessioni associative, cioè una parola funziona simultaneamente nella nostra mente in una varietà di relazioni paradigmatiche e sintagmatiche.
Semio e linguogenesi. Il codice genetico come primo sistema semiotico. (18 punti)
La semiogenesi è uno dei concetti più importanti della semiotica. Il concetto di semiogenesi è interpretato e sviluppato in due significati: in senso ampio e in stretto. Nel primo caso è associato alla sfera naturale dell'essere ed è destinato a caratterizzare il passaggio da forme di segnale animale a forme effettivamente semiotiche (simbolo e segno), in cui si realizza l'attività della coscienza umana. Nel secondo caso, la semiogenesi è direttamente limitata alla sfera cosciente della vita umana, che nella comprensione aggregata è anche interpretata come sfera di attività culturale, dove il ruolo dominante appartiene al simbolo - come forma a cui è associata ogni incarnazione materiale della cultura, e vettore universale della memoria culturale. In questo contesto, la semiogenesi è vista direttamente come l'evoluzione di un simbolo nella cultura.
Il codice genetico può essere paragonato a un testo scritto in una lingua il cui alfabeto contiene solo quattro lettere; A, T, G e C. Le regole sintattiche di questo linguaggio consentono solo alcune combinazioni di queste lettere nella formazione di "parole" di quattro lettere. La sequenza di tali parole forma il testo del messaggio su tutte le proprietà dell'organismo, cioè il suo codice genetico.
Il codice genetico è un sistema unificato di "registrazione" di informazioni ereditarie in molecole di acido nucleico inerenti agli organismi viventi sotto forma di una sequenza di nucleotidi. Il codice genetico è considerato il primo sistema semiotico.
Semiogenesi ed evoluzione. Il problema dell'origine del linguaggio umano. (18 punti)
Qual era la natura delle prime espressioni sane dell'uomo primitivo? Per quanto riguarda il loro contenuto, possiamo quasi con piena fiducia caratterizzarli come una richiesta di azione, come una richiesta di aiuto e non come una descrizione dei fatti. Se le prime espressioni dell'uomo primitivo dovessero essere espresse con l'aiuto del nostro linguaggio sviluppato, conterrebbero necessariamente verbi di umore imperativo ("dare!", "Trasportare!", "Spezzare!")
Testo. Coerenza del testo. Tipi di testi. Segni nel testo. L'uso dei segni nel testo. (18 punti)
Il linguaggio circonda una persona nella vita, lo accompagna in tutti i suoi affari, che lo voglia o no, è presente in tutti i suoi pensieri, partecipa ai suoi piani. Conoscere la nostra lingua madre, usare la parola ci sembra naturale e incondizionato come, ad esempio, la capacità di aggrottare la fronte o salire le scale. Nel frattempo, la lingua non nasce in una persona da sola, è un prodotto dell'imitazione e dell'apprendimento. L'uomo moderno come specie biologica è chiamato in latino Homo sapiens, cioè Homo sapiens. Ma l'homo sapiens è allo stesso tempo l'Homo loquens, una persona che parla. Per noi questo significa che il linguaggio non è solo una "comodità" che una creatura intelligente ha inventato per semplificarsi la vita, ma un prerequisito per la sua esistenza. La lingua è parte integrante del mondo interiore di una persona, della sua cultura spirituale, è un supporto per le azioni mentali, uno dei fondamenti delle connessioni mentali (associazioni), un aiuto per la memoria, ecc. È difficile sopravvalutare il ruolo del linguaggio nella storia della civiltà. Si può ricordare in questa occasione il noto aforisma del filosofo esistenzialista tedesco Martin Heidegger: "La lingua crea una persona" - o ripetere dopo lo scienziato russo Mikhail Bakhtin: "La lingua, una parola è quasi tutto nella vita umana".
Relazioni sintagmatiche (relazioni tra segni nel testo). Regole per combinare i segni. (18 punti)
Poiché le relazioni sintagmatiche sono osservate a tutti i livelli della struttura del linguaggio, nella linguistica moderna, a seconda delle unità di analisi scelte, parlano di sintagmatica come parte della disciplina di livello corrispondente e distinguono sintagmatica fonetica, fonologica, morfologica, lessicale, ecc.
L'assegnazione delle relazioni sintagmatiche è solitamente associata al nome di F. de Saussure. Secondo de Saussure, dei due tipi di relazioni che determinano il sistema del linguaggio e il suo stato in ogni momento della sua esistenza - sintagmatico e paradigmatico - i primi sono direttamente osservabili e basati sulla natura lineare del discorso e sulla proprietà della sua lunghezza, unicità, sequenza. Grazie a ciò gli elementi, susseguendosi, formano una certa catena linguistica, la sequenza è un sintagma, all'interno del quale i suoi elementi costitutivi entrano in relazione sintagmatica. Caratterizzano i collegamenti delle unità che si susseguono e sono determinati dal loro contrasto; l'elemento linguistico può quindi essere contrapposto o al precedente, oppure al successivo, oppure entrambi contemporaneamente. Per identificare queste relazioni, vengono sviluppate procedure speciali per la segmentazione o divisione del testo (discorso), che consentono di distinguere e separare un'unità da un'altra in base alla proprietà della sua ripetibilità e contrasto con le unità vicine. Poiché quasi tutte le unità linguistiche dipendono sia da ciò che le circonda nel flusso del discorso, sia da quelle parti di cui esse stesse consistono, lo sviluppo delle procedure di analisi sintagmatica procede secondo due diverse linee: il metodo di analisi di valenza è associato alla prima proprietà (vedi. Valence) e - più in generale - le proprietà di compatibilità delle unità linguistiche, con la seconda - i concetti e metodi di analisi distributiva.
Tutti i segni in tali sistemi sono interdipendenti.
La struttura del sistema di informazioni sui segni dipende dalla composizione e dalla complessità dei messaggi che devono essere codificati in esso. La gerarchia in questo sistema è la seguente: un segno (3) come sostituto di un determinato oggetto o fenomeno, un sistema di segni (S) come sostituto di un certo insieme di oggetti e un vettore di informazioni sul sistema di oggetti designati, un modello di segno (ZM) come un insieme di diversi sistemi di segni usati per codificare messaggi complessi.
In una situazione di segno, si riflettono le relazioni di segno che sorgono nell'attività umana. Queste relazioni di segno si realizzano attraverso le principali funzioni che segni e GS svolgono nell'attività umana
Proprietà dei sistemi di segnaletica. Regole per l'uso e l'interazione dei sistemi di segnaletica. (18 punti)
Specificità del linguaggio come sistema di segni
Per la linguistica strutturale, che consente la possibilità di descrivere una lingua come un sistema immanente e autonomo, le seguenti proprietà di un segno linguistico sono di fondamentale importanza:
la sua natura differenziale, che fa di ogni segno linguistico un'entità sufficientemente autonoma e non gli consente, in linea di principio, di mescolarsi con altri segni della stessa lingua; la stessa disposizione si applica agli elementi non di segno della lingua (che formano un piano di espressione di segni fonemi, sillabemi, prosodemi; che formano una pianta del contenuto di segni / semantemi di significato);
derivante da opposizioni paradigmatiche tra segni, la possibilità che il segno non abbia un significante materiale (cioè l'esistenza all'interno di un certo paradigma di un segno linguistico con esponente zero);
la natura bilaterale del segno linguistico (in accordo con gli insegnamenti di F. de Saussure), che ci spinge a parlare della presenza dell'uno o dell'altro significato linguistico solo se esiste un modo regolare di esprimerlo (cioè una stabile, stereotipata, esponenziale regolarmente riprodotta nel discorso), e la presenza di uno stereotipo significato da questo o quell'espositore;
la natura casuale e condizionale della connessione tra il significato e il significante;
estrema stabilità nel tempo e allo stesso tempo possibilità di cambiare sia il significante che il significato.
I segni linguistici possono essere suddivisi in classi di segni completi, ad es. comunicativamente completato,
autosufficienti (testi, dichiarazioni) e segni parziali, ad es. comunicativamente non autosufficiente
(parole, morfemi). La linguistica si è tradizionalmente concentrata sui segni dei nomi (parole). La semiotica più recente concentra la sua attenzione sull'affermazione come segno completo, con cui è correlato non un elemento separato dell'esperienza, ma una certa situazione olistica, uno stato di cose.
Coesistenza parallela di segni di sistemi diversi nell'atto comunicativo e nel testo. (18 punti)
Traduzione e traslitterazione. Riutilizzo dei segni. (18 punti)
La traslitterazione (abbreviazione di "traslitterazione") è un metodo per scrivere testo o parole non latine in lettere latine. La traslitterazione viene spesso utilizzata al posto dell'alfabeto cirillico quando si lavora su sistemi non russi per inserire nomi di file, nonché per tradurre nomi o nomi da una lingua all'altra. Questo servizio online traduce il testo russo (cirillico) in traslitterazione, cioè l'alfabeto latino o inglese.
Creolizzazione. Sistemi di segnaletica creolizzata. (18 punti)
Testo creolizzato - testo, la cui trama è costituita da due parti eterogenee: verbale (linguistico / vocale) e non verbale (appartenente ad altri sistemi di segni oltre al linguaggio naturale). Esempi di testi creolizzati sono pubblicità, fumetti, cartelloni pubblicitari, manifesti.
La creolizzazione è "una combinazione di mezzi di diversi sistemi semiotici in un complesso che soddisfa la condizione di testualità".
Le lingue creolizzate sono lingue che sono emerse dalla mescolanza di altre due lingue e sono stabilite in una parte della società. Lingua franca è la designazione per tutte le lingue. La creolizzazione del linguaggio è la sua semplificazione.
Rumore semiotico. Tipologia di errori di comunicazione. Errore di comunicazione. (18 punti)
Qui possiamo dire del rumore al cinema, sia nel fotogramma che dietro il fotogramma. (un uomo cammina da solo, ma il suono di una compagnia di soldati è un simbolo della sua forza)
fallimento comunicativo
Gli interlocutori hanno stereotipi diversi riguardo al comportamento del superiore con i subordinati e viceversa; di conseguenza, ciascuno degli interlocutori può essere scioccato dal comportamento dell'altro. Il grado di significatività delle differenze di stato sarà valutato dagli interlocutori in diversi modi; di conseguenza, chi lo percepisce come poco significativo farà la scelta sbagliata delle strategie di comunicazione.
È più comune per i rappresentanti delle culture collettiviste concentrarsi sullo status sociale dell'interlocutore; il loro atteggiamento nei confronti dell'interlocutore è in gran parte determinato da questo fattore. Il contesto situazionale può, da un lato, regolare la scelta del partecipante a seconda del grado di formalità della situazione, e può anche causare (o non causare) un certo grado di sincerità nella relazione. D'altra parte, il nostro atteggiamento nei confronti dell'interlocutore dipende dal fatto che ci concentriamo sulle qualità personali della persona o su fattori situazionali. Come puoi vedere, qui sorgono anche zone a rischio.
Quando le culture collettivista e individualista interagiscono, gli errori sono possibili da entrambe le parti. E, a quanto pare, è proprio l'enfasi sull'identità personale a scapito dell'identità sociale dell'interlocutore che può portare a conseguenze negative se appartiene a una cultura collettivista.
Errore di comunicazione
un effetto perlocutionary inaspettato (vedi perlocution), che mostra che l'intenzione di chi parla (per ottenere informazioni, avvertire, ecc.) non ha raggiunto il suo obiettivo. È possibile. ad esempio, in una situazione in cui, invece di rispondere a una domanda, non è un messaggio di informazione che suona, ma una domanda di contro-ripetizione (Dov'eri ieri? - Ieri?).
La lingua come sistema di segni. Segni linguistici, loro struttura e funzionamento. Struttura linguistica. Teoria del linguaggio. (18 punti)
La lingua come sistema di segni
La lingua come sistema di segni più importante differisce da tutti gli altri sistemi di segni ausiliari (specializzati).
Il sistema di segni linguistici è un mezzo completo per trasmettere e memorizzare informazioni, così come il design del pensiero stesso, l'espressione delle emozioni, la valutazione e l'espressione della volontà, mentre i sistemi di segni specializzati servono a trasferire informazioni limitate, ricodificando il già noto.
Significato strutturale di un segno linguistico
Il significato è una funzione semantica di un'unità linguistica, perché queste unità, avendo un proprio contenuto, formano la forma interna del pensiero. Il significato delle unità linguistiche non è oggetto del pensiero dell'oratore, se non rivolge la sua attenzione su di esse. Il significato delle unità linguistiche è astratto dai loro correlati extra-linguistici e dalla loro concretezza, e in questo senso il linguaggio ha solo un formale generale e formale, ma sostanziale.
I significati lessicali e grammaticali di un segno linguistico possono essere considerati come il contenuto di un segno linguistico. Questi significati non coincidono con il significato dell'unità di vocabolario e il significato della forma grammaticale, che compaiono in una parola significativa.
Il significato lessicale differisce da quello grammaticale, cento è legato a singole parole, mentre il significato grammaticale è caratteristico non di una parola particolare, ma della lingua nel suo insieme: qualsiasi significato lessicale può manifestarsi solo attraverso un significato comune - lessicale di gruppo e grammaticale. Il significato grammaticale è quindi un modo di rappresentare il significato lessicale. Quindi, il concetto di nero non può esistere affatto; esiste solo come nero (segno), nero (oggettività), annerimento (azione), ecc.
I significati grammaticali come concetti di classificazione e proprietà semantiche categoriali di una lingua sono obbligatori per tutti i parlanti di una data lingua;
i significati lessicali sono usati a vari livelli dai parlanti - a seconda della disponibilità di conoscenze speciali, familiarità con il vocabolario della lingua e padronanza delle risorse stilistiche della lingua. La variabilità dei significati lessicali, la loro sinonimia è molto più ampia e diversificata rispetto alla varianza e sinonimia dei significati grammaticali.
La divisione dei significati linguistici in lessicali e grammaticali significa la loro relazione, la presenza di casi di transizione e ulteriori chiarimenti. È necessario distinguere, in primo luogo, i significati del modello di unità linguistica e specifiche unità linguistiche; Secondo, tipi diversi unità (ad esempio, morfemi e forme di parole, frasi e frasi). Infine, le unità linguistiche sono semplici e complesse (lessema e unità fraseologica, forma sintetica e analitica di una parola, ecc.), E questo influenza la struttura del loro significato.
Parlando di significati linguistici strutturali, dobbiamo distinguere tra significati indicativi e caratterizzanti. I significati indicativi (denotazioni) significano e nominano un significato o una relazione; i significati caratterizzanti (disignata) esprimono un atteggiamento nei confronti di questo significato o relazione: sono, per così dire, significati sui significati, rapporti con le relazioni.
Questi tipi di significati sono anche chiamati altri termini: il primo - significante, nominativo, mentre il secondo - denotante, semantico, modale, modale-semantico. Ci sono soprattutto molti termini per i nomi di tipi di significati in relazione al significato lessicale di una parola, e molti di loro derivano dalla logica e dalla semiotica: referente e simbolo, denotazione e designatum (significatum), significato e significato, ecc. Va sottolineato che il significato strutturale di linguistico le unità, le loro categorie e modelli (semantici e riproducibili per loro natura) non sono l'oggetto diretto del messaggio. Il significato lessicale, che possiede un contenuto nominativo e designativo, nel discorso è pieno di significato concreto e riceve un significato denotativo e connotativo aggiuntivo (stilistico). Pertanto, il significato lessicale (oltre che grammaticale) viene utilizzato per organizzare e trasmettere la semantica non linguistica, un messaggio specifico.
Modelli linguistici e modelli linguistici. Funzioni e livelli di linguaggio. (18 punti)
La struttura di una lingua è un insieme di connessioni e relazioni regolari tra unità linguistiche, che dipendono dalla loro natura e determinano l'originalità qualitativa del sistema linguistico nel suo insieme e la natura del suo funzionamento.
Una relazione è il risultato del confronto di due o più unità linguistiche per una base o caratteristica comune.
2. MODELLO DI LIVELLO DEL SISTEMA LINGUISTICO
I livelli linguistici sono disposti in relazione tra loro secondo il principio della complessità ascendente o discendente delle unità linguistiche. L'essenza di questo fenomeno risiede nella conservazione delle proprietà e delle caratteristiche delle unità del livello inferiore nel sistema del livello superiore, ma già in una forma più perfetta. Pertanto, la relazione tra i livelli del sistema linguistico non è riducibile a una semplice gerarchia: subordinazione o ingresso. Pertanto, è giusto chiamare un sistema linguistico un sistema di sistemi.
L'inizio della segmentazione del flusso vocale è la selezione di unità comunicative in esso - affermazioni o frasi. Nel sistema linguistico, corrisponde a un sintassema o modello sintattico che rappresenta il livello sintattico della lingua. La fase successiva della segmentazione è la divisione delle espressioni in forme verbali, in cui vengono combinate più funzioni eterogenee (nominativa, derivazionale e relazionale), pertanto l'operazione di identificazione viene eseguita separatamente per ciascuna direzione.
La classe delle forme verbali, caratterizzate dalla stessa radice e dai morfemi affissi, è identificata nell'unità di base della lingua: una parola o un lessema.
La fase successiva della segmentazione del flusso vocale consiste nella selezione delle unità significative più piccole: i morph. Morph con identici significati lessicali (radici) e grammaticali (servizio e affisso) sono combinati in un'unica unità linguistica: un morfema. L'intero insieme di morfemi di una data lingua forma un livello di morfema nel sistema linguistico. La segmentazione del flusso vocale è completata dalla selezione nei morph dei segmenti minimi del parlato: i suoni. I suoni, o sfondi, diversi nelle loro proprietà fisiche, possono svolgere la stessa funzione di distinzione dei sensi. Su questa base, i suoni vengono identificati in un'unità linguistica: un fonema. Un fonema è la più piccola unità di una lingua. Il sistema fonematico costituisce il livello fonologico della lingua.
Pertanto, l'assegnazione di un livello o sottosistema di una lingua è consentita nel caso in cui: il sottosistema ha le proprietà di base del sistema linguistico nel suo complesso; il sottosistema soddisfa il requisito di costruttività, cioè le unità del sottosistema servono a costruire le unità del sottosistema di un'organizzazione superiore e sono isolate da esse; le proprietà di un sottosistema sono qualitativamente diverse dalle proprietà delle unità del sottosistema sottostante che lo costruiscono; un sottosistema è definito da un'unità linguistica che è qualitativamente diversa dalle unità dei sottosistemi adiacenti.
La particolarità del modello di livello del sistema linguistico è il desiderio di presentare il linguaggio come uno schema simmetrico e idealmente ordinato. Questa idea, di per sé piuttosto attraente, non è del tutto adeguata, poiché il linguaggio non è un sistema assolutamente armonioso, simmetrico e idealmente ordinato. Pertanto, il modello di campo del sistema linguistico sta diventando sempre più popolare.
3. MODELLO DI CAMPO DEL SISTEMA LINGUISTICO
Il principio principale della modellazione sul campo del sistema linguistico è l'unificazione delle unità linguistiche in base alla comunanza del loro contenuto: semantico e funzionale. Le unità dello stesso campo linguistico riflettono la somiglianza oggettiva, concettuale o funzionale dei fenomeni designati. Il modello di campo dimostra la connessione dialettica tra i fenomeni linguistici e il mondo extra-linguistico. Il nucleo e la periferia si distinguono in esso. Il nucleo concentra in sé l'insieme massimo di caratteristiche di formazione del campo. La periferia è formata da unità linguistiche con un insieme incompleto di queste caratteristiche e la loro intensità può essere notevolmente indebolita. Di solito sono formazioni espressive.
I criteri per identificare il nucleo e la periferia sono stati sviluppati dai linguisti cechi.
Sorge la domanda, cosa significa l'apprendimento sistemico-strutturale di una lingua, quali aspetti della lingua vengono appresi in modo particolarmente profondo ed efficace. Dovrebbe essere risposto come segue.
1. I principi sistemici servono come base metodologica per la costruzione di moderne teorie linguistiche, per il principio di campo dell'apprendimento delle lingue straniere.
2. Le funzioni della lingua sono considerate nella loro interazione sistemica.
3. Il sistema linguistico viene confrontato con altri sistemi di segni.
4. La classificazione delle lingue viene effettuata su una base di sistema unico.
5. Il principio di coerenza viene introdotto nello studio storico comparato delle lingue.
6. Vengono chiarite le connessioni e le relazioni sistemiche, la loro specificità ai diversi livelli strutturali del linguaggio e tra i livelli.
Pertanto, i criteri iniziali del sistema linguistico sono: a) la sua integrità; b) la relativa indivisibilità degli elementi del sistema; c) organizzazione gerarchica; d) struttura.
Teorie e modelli linguistici di base (revisione).
e l'intera gamma di compiti relativi alle attività umane:
a) la teoria del linguaggio, che stabilisce strutture sonore, morfologico-sintattiche e logiche e coincide per molti aspetti con la teoria della grammatica, deve essere compatibile con la modellizzazione dei processi interpretativi,
b) la teoria della conoscenza quotidiana, che rivela la struttura dei sistemi concettuali che determinano l'elaborazione percettiva, cognitiva e motoria del mondo circostante,
c) la teoria dell'interazione sociale, che indaga le strutture delle relazioni interpersonali, una manifestazione particolare delle quali sono le azioni comunicative. L'opposizione dei sistemi di conoscenza ai processi e ai meccanismi del loro utilizzo è al di fuori dell'ambito di questa divisione in tre parti, consentendo di modificare ciascuna delle parti di questo modello. E tali modifiche sono un risultato naturale della crescita teorica ed empirica di tutte le suddette discipline correlate. Un posto importante in questo è occupato dalla conoscenza scientifica e dalla sua ricerca: nell'interpretare il discorso, usiamo non solo conoscenze ordinarie, ma anche abbastanza speciali, specialmente quando si tratta di scienza; Allora sorge spontanea la domanda: quali sono i meccanismi di "trasferimento" della conoscenza nella composizione delle idee quotidiane? Finora, non c'è dubbio solo che l'attività vocale sia direttamente correlata a questo meccanismo.
Il ruolo della significazione nella cultura. Esempi di significato culturale delle cose (simbolismo di colori, numeri, linguaggio dei segni, linguaggio dei fiori, danza, pietre e segni, ecc.) (18 punti)
La cultura come modo di intendere la vita
Questo esempio mostra che l'aspetto della cultura è formato dalla vita stessa, in questo caso, dalla vita comunità religiosa... In altre comunità, eventi, fatti e relazioni di un ordine completamente diverso saranno significativi. Ma ogni volta, per capire cosa sta succedendo, per influenzarlo, per possederlo, le persone che compongono questa o quella comunità devono essere in grado di descrivere con mezzi simbolici le manifestazioni essenziali della propria vita, "significarle" e quindi renderle fatti culturali.
Tutti i rami della conoscenza del mondo antico, questi predecessori delle scienze future, sono nati da questo bisogno di significare ciò che stava accadendo. Intendevano quanto potevano, come potevano, come ritenevano ragionevole. La necessità di regolare i rapporti tra le persone ha dato origine - come forma del loro significato - a una legislazione antica. La necessità di tenere conto delle dimensioni dei campi, dei volumi di stoccaggio, delle masse di grano, di tenere conto del rapporto tra le dimensioni nella costruzione di edifici, navi, muri difensivi, condotte idriche, ecc. Ha dato origine all'antico sistema matematico di segni e regole per le operazioni con essi.
Intendono non solo ciò che vedono, ma anche ciò in cui credono. La cultura medievale è ricca di segni che rimandano a realtà ultraterrene. Icone, mosaici, rilievi e altre immagini significano la vita come era intesa nel Medioevo, considerando l'aldilà di una persona come la stessa realtà di quella terrena. In Unione Sovietica si credeva che "la terra inizi, come sai, dal Cremlino ...". Questa è anche una sorta di designazione (a parole) dell'idea sovietica della struttura del mondo. La fede in un tale ordine mondiale era considerata una parte importante della vita pubblica: chi la pensava diversamente rischiava molto. Giornali, manifesti, film, programmi televisivi hanno mostrato la posizione centrale dell'URSS nel mondo.
Solo quegli eventi ed esperienze in cui si rivela il significato sociale sono soggetti a significato. Il resto della cultura "non vede", li ignora. Pertanto, gli stessi fatti della vita possono diventare fatti culturali in una comunità e non diventarli in un'altra. Ad esempio, la nascita del primo figlio nella famiglia di un monarca è un fatto di fondamentale importanza in una cultura che riconosce l'eredità del potere tramite il sangue. Tuttavia, non è sempre facile spiegare perché un fatto della vita è più socialmente significativo di un altro, ad esempio perché il matrimonio di un famoso attore cinematografico è importante e significativo per il grande pubblico, ma il matrimonio di un importante progettista di aerei non lo è. In ogni caso, però, possiamo dire che nella cultura non c'è niente che non esista nella vita.
Segni nella lingua. Verità e bugie. Senso. (18 punti)
La lingua è un sistema di segni utilizzato per memorizzare e trasmettere informazioni.
Sono disponibili lingue dei seguenti tipi:
- naturale: si tratta di sistemi aperti e auto-sviluppanti (russo, inglese, cinese, ecc.);
- artificiali - sistemi chiusi (linguaggi della scienza, linguaggi di programmazione, ecc.).
Lo studio del linguaggio come sistema di segni è impegnato nella scienza della semiotica, che comprende sezioni come:
- sintassi - la teoria della relazione di un segno con un altro, ad es. la teoria del collegamento dei segni in complessi di segni usati nella comunicazione;
- semantica - una teoria che studia la relazione di un segno con il suo significato e significato;
- pragmatica - una teoria che descrive come i madrelingua usano i segni.
Un segno è un oggetto materiale (fenomeno, evento) che funge da rappresentante di qualche altro oggetto, proprietà o relazione e viene utilizzato per acquisire, memorizzare, elaborare e trasmettere messaggi (informazioni, conoscenza).
Il significato del soggetto di un segno è un oggetto sostituito. Un oggetto simile possono essere oggetti, nel senso ampio del termine: tutto ciò che può diventare oggetto di pensiero, tutto ciò su cui qualcosa può essere affermato o negato. Anche le caratteristiche degli oggetti possono agire in questa veste. In generale, i significati dei soggetti dei segni sono diversi. A volte è persino difficile stabilire cosa siano per certi tipi di segni. In particolare, questo vale per le offerte. Con un alto grado di convenzionalità nella logica, si ritiene che i significati oggettivi delle frasi dichiarative siano oggetti astratti come verità e falsità. Ciò significa che una frase dichiarativa indica la presenza di determinate informazioni (vere o false) relative a una determinata area della realtà. Le frasi interrogative rappresentano situazioni in cui, al contrario, mancano certe informazioni e la necessità di averle. Le frasi di incentivazione sono segni dei nostri desideri, aspirazioni, bisogni.
La pragmatica del linguaggio dei segni e la pragmatica della lingua. (18 punti)
La pragmatica è una sezione della semiotica che studia la relazione dei segni (vedi: Segno) con i soggetti che li producono e li interpretano. La pragmatica, di regola, è considerata nell'ambito del campo interdisciplinare di ricerca dei segni e dei sistemi semiotici della semiotica (vedi: Semiotica) insieme alle sue altre due sezioni: semantica (vedi: Semantica) e sintattica (vedi: Sintattica). Il primo di loro considera i segni nella loro relazione con oggetti designati (non aventi una natura di segno), il secondo - la relazione dei segni tra loro (sintassi). La materia di studio più importante per la pragmatica è l'aspetto pragmatico del linguaggio (vedi: Lingua).
Il termine "pragmatica" è stato introdotto alla fine degli anni '30 del XX secolo da C. W. Morris per designare una delle tre sezioni della semiotica (insieme a sintattica e semantica). Tuttavia, l'aspetto molto pragmatico dell'esistenza dei sistemi di segni (inclusa la lingua) fu attentamente considerato da Charles S. Peirce alla fine del XIX secolo. Peirce (come Morris, che seguì ampiamente le sue idee) considerava la componente pragmatica quella principale per determinare l'essenza del segno. Il segno diventa tale non per le sue proprietà fisiche, ma per il suo uso certo nella comunità. Pertanto, sia il metodo di costruzione delle strutture dei segni (sintassi) che la relazione dei segni con gli oggetti designati (semantica) sono solo un mezzo per i segni per svolgere la loro funzione principale: fornire la comunicazione tra le persone. Secondo Peirce, la cognizione è il processo di mediazione della realtà mediante segni. La necessità di mediazione nasce perché l'attività cognitiva non è svolta da un soggetto isolato (come la tradizione filosofica che viene da R. Descartes cerca di presentarla), ma da una comunità, che nelle sue azioni congiunte sviluppa un'idea generale del mondo. Il processo di cognizione consiste nella produzione e interpretazione di segni (principalmente linguistici). In questo senso, la verità, secondo Peirce, non è la corrispondenza dei giudizi a qualche stato di cose oggettivo. Rappresenta un consenso all'interno della comunità. In altre parole, la verità non è un concetto semantico (come è rappresentato, ad esempio, da A. Tarski), ma un concetto pragmatico.
Il ruolo speciale della dimensione pragmatica del linguaggio nella cognizione e nell'attività razionale è generalmente notato nei concetti filosofici sviluppati dai filosofi tedeschi J. Habermas e K.-O. Apel. Una caratteristica comune che li distingue dalla maggior parte degli altri ricercatori che si occupano dei problemi della pragmatica linguistica è una sorta di assolutismo. Questo assolutismo, espresso, in particolare, nei nomi dei loro concetti ("pragmatica universale" in Habermas e "pragmatica trascendentale" in Apel), consiste nella ricerca di norme di comunicazione universali (universali o trascendentali) inerenti a tutta la comunicazione umana.
Assiomi e postulati della semiotica. (18 punti)
Un assioma è una formalizzazione di base (non un'affermazione che richiede una giustificazione) di un fatto empiricamente affidabile nel quadro di una data teoria (nelle condizioni d'uso al contorno).
Un esempio di assioma in cui la sua affidabilità non dipende da una valutazione soggettiva: si tratta di una qualsiasi formalizzazione della legge di natura, che viene riprodotta da qualsiasi ricercatore a determinate condizioni. Ad esempio, tutte e tre le leggi di Newton sono assiomi che descrivono le leggi fondamentali della natura, la cui essenza è ancora sconosciuta. Questi assiomi sono oggettivamente affidabili nel quadro delle condizioni della teoria della meccanica classica e non dipendono dalla valutazione del soggetto. L'essenza di questi assiomi è la formalizzazione di una legge di natura empiricamente affidabile.
Il concetto di opposizione semiotica. Esempi di opposizione semiotica. (18 punti)
OPPOSIZIONE LINGUISTICA (dal lat. Oppositio - opposizione), differenza linguisticamente significativa (che svolge una funzione semiologica) tra le unità del piano di espressione, che corrisponde alla differenza tra le unità del piano di contenuto. In questo senso, si parla di opposizione fonologica, ad esempio, tra i fonemi russi / k / e / r / (le parole gatto e bocca differiscono non solo nel suono, ma anche nel significato), o dell'opposizione semantica "singolare". - "plurale" (poiché, ad esempio, esiste una distinzione sia sostanziale che formale tra tavolo e forme del tavolo). Questa interpretazione consente di utilizzare il concetto di opposizione per distinguere tra la relazione tra le diverse unità linguistiche - la cosiddetta relazione di opposizione - e la relazione tra diverse opzioni della stessa unità linguistica - relazione non positiva.
Quindi, ad esempio, le consonanti sorde retro-linguali [k] e [x], la prima delle quali è occlusiva e la seconda fricativa, sono fonemi diversi della lingua russa (cfr. Morbillo e cor), mentre le corrispondenti consonanti sonore [g] e [g] , tra le quali c'è la stessa differenza fonetica, sono varianti dello stesso fonema, da allora sostituire l'uno con l'altro non è associato a una distinzione significativa: cfr. bo [g] lanciato insieme al più comune bo [g] lanciato.
Leggi fondamentali della semiotica. (18 punti)
Fin dal suo inizio, le leggi della semiotica sotto forma di una scienza separata sono state divise in tre delle sue sezioni, a cui uno dei suoi fondatori, C. Morris, ha dato i seguenti nomi: sintattica, che studia la relazione tra i segni; semantica - studio della relazione tra segni e soggetto designato; pragmatica: lo studio della relazione tra un segno e una persona. La divisione in tre sezioni risale alla divisione delle scienze nel Medioevo (vedi I, 2) e rimane in semiotica anche adesso1. Ma il contenuto di ciascuna sezione si espanse in modo significativo a causa del fatto che appariva una semiotica particolare e concreta, mentre C. Morris stabiliva la sua divisione in relazione alla semiotica astratta, che da sola era sufficientemente sviluppata ai suoi tempi. Ora, il rapporto della semiotica particolare con le parti indicate della semiotica generale, da un lato, è il seguente: 1) la biosemiotica, che studia la questione di come nel processo di evoluzione qualcosa ha cominciato a significare qualcosa, più corrisponda alla semantica; 2) entosemiotica - pragmatica; 3) semiotica astratta - sintattica (per maggiori dettagli si veda la Nota 54 al Capitolo II). La linguosemiotica risponde a tutti
tre parti, poiché lei stessa è il prototipo della semiotica generale. Ma queste sono corrispondenze piuttosto storiche. L'essenza stessa della semiotica generale è che esamina le leggi generali, traendo materiale per generalizzazioni in varie semiotiche particolari. È più importante sottolineare questo aspetto nelle leggi semiotiche. Le divideremo in tre gruppi: a) leggi oggettive della struttura dei sistemi di segni (sintattiche); b) leggi che dipendono dalla posizione dell'osservatore (pragmatico); c) le leggi del significato (semantica). Questa classificazione è, ovviamente, arbitraria e relativa. Se una legge può essere attribuita sia all'una che all'altra sezione, viene attribuita alla prima in ordine. Ogni legge è illustrata da uno schizzo più o meno dettagliato.
29) L'ipotesi di Sapir-Whorf. Varie interpretazioni dell'ipotesi. Conseguenze dell'ipotesi. (18 punti)
L'ipotesi della relatività linguistica presuppone che la struttura di una lingua influenzi la percezione del mondo e le visioni dei suoi parlanti, nonché i loro processi cognitivi. La relatività linguistica è ampiamente nota come ipotesi di Sapir-Whorf. Esistono due formulazioni di questa ipotesi:
Versione rigorosa: la lingua definisce il pensiero e, di conseguenza, le categorie linguistiche limitano e definiscono le categorie cognitive.
Versione soft: pensare insieme alle categorie linguistiche determina l'influenza delle tradizioni e di alcuni tipi di comportamento non linguistico.
Il termine "ipotesi Sapir-Whorf" è, infatti, errato, poiché Edward Sapir e Benjamin Whorf non sono mai stati coautori e non hanno mai affermato le loro idee come ipotesi scientifiche. L'emergere di una versione rigida e morbida dell'ipotesi è anche un'innovazione successiva: sebbene Sapir e Whorf non abbiano mai deliberatamente fatto una tale distinzione, si possono trovare descrizioni sia rigide che morbide del principio di relatività nelle loro opere.
Una versione rigorosa della teoria linguistica relativistica fu sviluppata all'inizio degli anni '20 dal linguista tedesco Leo Weisgerber.
Il principio del relativismo linguistico di Whorf è stato riformulato sotto forma di ipotesi scientifica dallo psicologo Roger Brown e dal linguista Eric Lenneberg, che hanno condotto esperimenti per scoprire se la percezione del colore dei partecipanti all'esperimento dipende da come i colori sono classificati nelle loro lingue native.
Attualmente, la maggior parte dei linguisti detiene una posizione riservata rispetto al relativismo linguistico: l'idea è supportata che il linguaggio influenzi alcuni tipi di processi cognitivi, anche se in modi non ovvi, ma altri processi stessi sono soggetti in relazione a fattori universali. La ricerca si concentra sulla scoperta di questi percorsi di influenza e sul determinare in che misura il linguaggio influenza il pensiero.
John Lucy ha identificato tre principali aree di ricerca nel relativismo linguistico. Il primo ha definito un approccio "centrato sulla struttura". La ricerca con questo approccio inizia con l'osservazione delle caratteristiche strutturali del linguaggio e quindi passa all'esame delle possibili conseguenze per il pensiero e il comportamento. Il primo esempio di tale ricerca è l'osservazione di Whorf delle discrepanze nella grammatica del tempo in Hopi e in inglese. Successivamente, la ricerca in questo spirito fu condotta da John Lucy, descrivendo sia l'uso delle categorie grammaticali dei classificatori numerici che dei classificatori numerici nella lingua yucateca. Questi studi hanno dimostrato che i parlanti yucatechi tendono a classificare gli oggetti in base al loro materiale piuttosto che alla loro forma, come preferiscono fare i madrelingua inglesi.
La seconda direzione della ricerca è l'approccio "regionale", quando un'area semantica separata viene selezionata e confrontata tra diversi gruppi linguistici e culturali al fine di trovare correlazioni tra i mezzi linguistici utilizzati in una lingua per designare determinati concetti,
(LSLT, 1955-56)
Nell'emergere della grammatica trasformazionale-generativa, il libro di Chomsky (1975) Struttura logica della teoria linguistica(LSLT) è di 570 pagine in una posizione insolita. Da un lato, questo è il lavoro fondamentale alla base dell'intera teoria e, dall'altro, non è stato pubblicato fino al 1975. Cronologicamente, i suoi capitoli principali hanno preceduto gli importanti rapporti di Chomsky nel 1956 e Strutture sintattiche(1957a) Per alcuni aspetti, l'LSLT è ancora all'interno della tradizione dello strutturalismo nordamericano, in particolare la discussione sui metodi di scoperta e le procedure di sostituzione nel Capitolo V. Dal punto di vista dei linguisti corporei, la seguente affermazione programmatica nella nota a piè di pagina è piuttosto interessante:
(2) “La nostra intera discussione si basa sul presupposto che i dati vengano raccolti - che la grammatica sia basata su un corpus adeguato. Non abbiamo discusso di più domanda importante Di, comeviene compilato il corpus e come il linguista riceve le informazioni sul comportamento linguistico. Vedere Lounsbury, "Metodi e tecniche sul campo in linguistica"; Harris e Voegelin, "Eliciting" "
(Chomsky 1975, 227; corsivo nell'originale).
In questa fase della teoria trasformazionale-generativa, Chomsky sembra davvero considerare la disponibilità di adeguati corpora rappresentativi di testi come un punto di partenza evidente per la descrizione linguistica, insieme a informazioni congetturali sul "comportamento linguistico". Secondo i riferimenti al lavoro di Lounsbury (1953) e Harris e Voegelin (1953), Chomsky si riferiva principalmente alla metodologia del corpus di campo strutturalista basata sulla verifica con l'aiuto dell'informatore. Naturalmente, questa metodologia è stata sviluppata principalmente per lo studio di lingue "esotiche" precedentemente sconosciute al linguista di campo, e quindi non aveva alcuna relazione diretta con il lavoro grammaticale con lingue ben note con una lunga tradizione scritta e tradizioni consolidate di descrizione grammaticale.
È sorprendente che Chomsky accenni a questo assunto solo in una nota a pagina 227, dopo aver fatto decine di riferimenti sull'importanza dei corpora. Ecco alcuni esempi: "avendo un corpus di materiale linguistico", si possono confrontare le varie grammatiche offerte e scegliere la migliore (p. 61); "Avendo un corpus", è possibile creare un insieme di livelli descrittivi compatibili (p. 68); nella descrizione grammaticale, “abbiamo<…> solo un corpus finito di enunciati da un insieme infinito di enunciati grammaticalmente corretti ”(p. 78); "[Abbiamo] suggerito che la grammatica venga testata dimostrando che deriva dall'applicazione del corpus a una teoria generale ben formulata" (p. 86); "[La grammatica] deve generare un insieme di frasi grammaticalmente corrette basate su un corpus limitato" (p. 94); “Avere un corpus di frasi per le quali, come sappiamo in anticipo, esiste una grammatica” (p. 166); "Avendo un corpus di frasi", il linguista deve determinare quali di queste frasi sono distinguibili fonemicamente (p. 129); “Un insieme di frasi grammaticalmente corrette non può essere identificato con il corpus di frasi osservabili creato da un linguista” (p. 129); “Dobbiamo proiettare la classe di frasi osservate su<…> una classe infinita di frasi grammaticalmente corrette ”(p. 133); "Facciamo finta<…> guarda l'uomo strabico trovato nel corpus ”(p. 133); “Ci è stato dato il Kche consideriamo un insieme di stringhe di parole ”(p. 134); “Definiamo distribuzioneparole come insieme di contesti nel corpus in cui ricorre ”(p. 137); "Supponiamo<…>che tutte le frasi del corpus hanno la stessa lunghezza ”(p. 140); “Nel materiale linguistico reale, le restrizioni di selezione sulla distribuzione sono estremamente rigide” (p. 141); "Avendo un corpus di frasi, definiamo un insieme G come un insieme di frasi che soddisfano le regole stabilite per descrivere questo corpus<…>"(P. 147); "Il metodo descritto nel § 35 non può fornire una risposta completa alla domanda di proiettare un corpus su una serie di frasi grammaticalmente corrette<…>"(P. 153); "Migliorare il livello Pastrattamente, ora possiamo provare a determinarne l'efficacia applicandola alla descrizione di materiale in linguaggio reale ”(p. 223); "Avendo un insieme di categorie grammaticali di primo ordine e un corpus linguistico, abbiamo un insieme di frasi generate" (p. 227).
Quindi, non c'è dubbio che in LSLT Chomsky abbia dato per scontata la metodologia del corpus strutturalista, come una componente ovvia nella cassetta degli attrezzi della linguistica generativa emergente. Tuttavia, è anche un dato di fatto che qui, come nei lavori successivi, lui stesso non applica mai questa metodologia e non solleva la questione se l'approccio trasformazionale-generativo alla linguistica avrà effettivamente bisogno di una nuova metodologia di corpus chiara. Piuttosto, senza alcuna discussione fondamentale nella LSLT, Chomsky introduce un nuovo metodo di utilizzo di esempi di fantasia grammaticalmente errati (o altrimenti strani), creati da lui stesso sulla base della sua intuizione grammaticale di un madrelingua, da usare come prova in la sua argomentazione sulla correttezza grammaticale. Ecco un elenco di esempi di questo tipo presentati nell'LSLT (nel 1955-56 non c'era la tradizione di usare asterischi o punti interrogativi per contrassegnare esempi non grammaticali o strani; il primo a usare gli asterischi per indicare errori grammaticali, per quanto ne so, è stato R. B. Liz (1957, 402), che, parlando della creazione di parole composte in inglese, ha fornito esempi come un libro per cucinare vs. * un libro di cucina):
Le idee verdi incolori dormono furiosamente.
Furiosamente dormire idee verde incolore.
La sincerità ammira John.
Il golf ammira John.
L'ammira John.
Di aver pranzato con Tom.
Guarda gli occhi strabici da.
La sincerità graffiata da John lo era<...>
Il tavolo manifestato da John era<...>
Se stesso è stato visto nello specchio da John.
La miseria ama la compagnia.
mal di denti della vittoria
La vittoria ha mal di denti.
un raccolto loquace
il considerato una persona sciocca
Sembra di John.
Sembra abbaiare.
Sembra perdonato.
John era stanco e applaudì.
Al clown, tutti risero.
L'ufficio è stato lavorato da John.
Nonostante i molti riferimenti programmatici all'importanza dei corpora, essi non vengono utilizzati in LSLT anche sotto forma di esempi genuini occasionali. Tuttavia, non vi è nemmeno una rottura netta con la metodologia del corpus strutturalista. Si noti, incidentalmente, l'affermazione di Newmeyer (1986, 66) che i primi libri e le prime conferenze di Chomsky sono pieni di polemiche contro le nozioni empiriche di scienza supportate dai linguisti strutturali. Non sono riuscito a trovare niente di simile nelle opere di Chomsky scritte prima del 1956.
D'altra parte, l'LSLT contiene anche molti riferimenti al concetto di intuizione linguistica. All'inizio del capitolo riassuntivo, Chomsky (ibid., 61-62) sostiene che la sua teoria "farà luce su tali fatti" che includono (i) la capacità dell'oratore di produrre un numero indefinito di nuove espressioni che sono immediatamente accettate da altri membri della comunità linguistica, e (ii) la capacità di avere "giudizi intuitivi sulla forma linguistica", in particolare, di identificare l'appartenenza di fonemi a suoni, di percepire parentele morfologiche (come in vedere : vista), identificare frasi correlate (come frasi dichiarative e le loro domande corrispondenti), definire schemi di frasi (come una varietà di esempi di proposizioni subordinate transitive) e percepire ambiguità strutturali (come Non sanno quanto sia buona la carne.).
Grammatica della lingua L cerca di considerare questi problemi in termini di proprietà formali delle affermazioni. La teoria che determina la correttezza grammaticale genera solo frasi grammaticalmente corrette, essendo "applicate al modello finale di comportamento linguistico", e dimostra che sono in armonia con i giudizi intuitivi del madrelingua, corrisponde al senso intuitivo della correttezza grammaticale del madrelingua ed è una "valutazione razionale di questo comportamento, ad es. la teoria dell'intuizione linguistica del parlante ”(ibid., 95). A prima vista, queste affermazioni forniscono un collegamento perduto tra i dati del corpus e l'intuizione come materiale di partenza o materia prima per la descrizione generativa, ma dobbiamo ancora affrontare il fatto che nella pratica reale non vengono utilizzati corpus.
I fautori di questi approcci allo studio della comunicazione si concentrano sul problema del linguaggio inteso come:
* un sistema di comunicazione simbolica, ad es. comunicazione attraverso segni vocali (e scritti), che distingue nettamente gli esseri umani da tutte le altre specie. La lingua è governata da regole e include molti segni convenzionali che hanno un significato comune per tutti i membri del gruppo linguistico;
* segno pratica in cui e attraverso il quale la personalità umana si forma e diventa un essere sociale.
Il teorico svizzero F. de Saussure è considerato il fondatore della moderna linguistica strutturale. Ha anche fortemente influenzato il movimento intellettuale noto come strutturalismo. La linguistica nel suo insieme Saussure si riferisce alla condotta della psicologia, evidenziando una scienza speciale - la semiologia, progettata per studiare i sistemi di segni, il più importante dei quali è il linguaggio.
All'interno della semiologia viene individuata la linguistica, che tratta il linguaggio come un sistema di segni di un tipo speciale, il più complesso nella sua organizzazione. Inoltre, viene fatta una distinzione tra l'analisi rigorosa meno significativa della linguistica esterna, che descrive le condizioni geografiche, etniche, storiche e altre condizioni esterne dell'esistenza di una lingua, da quella più significativa per il ricercatore di linguistica interna, che studia la struttura del meccanismo linguistico nella sua attrazione da fattori esterni... Indica la più grande ristrettezza di scrittura alla lingua nel cerchio dei sistemi di segni.
Per la comprensione teorica della lingua, sono importanti le opere di R. Yakobson, linguista e critico letterario russo, che ha avuto un'enorme influenza sullo sviluppo della linguistica teorica moderna e dello strutturalismo. Il suo approccio allo studio della letteratura e della poesia includeva l'analisi "strutturale", in cui la "forma" era separata dal "contenuto". Ha dato importanti contributi teorici alla linguistica studiando la fonologia (cioè i sistemi sonori di una lingua) analizzando i suoni al fine di rivelare l'insieme relativamente semplice di contrasti binari che sono alla base del linguaggio umano. Nel complesso, nell'analisi delle lingue e dei sistemi di segni umani, Jacobson ha suggerito l'esistenza di "invarianti strutturali" e differenze "superficialmente" evidenti tra le culture. L'enfasi sugli universali linguistici creava un contrasto con il concetto di linguaggio più culturalmente relativistico proposto dagli antropologi americani F. Boas ed E. Sapir. Così, E. Sapir e il suo studente B.L. Whorf ha avanzato l'ipotesi del relativismo linguistico, secondo il quale la nostra lingua è costruita sulla nostra percezione del mondo.
La semiologia o semiotica - la scienza generale dei segni - occupa un posto fondamentale nello studio del linguaggio. Come aspetto dello strutturalismo, la semiologia ha origine negli studi linguistici di Saussure. Il suo principale rappresentante era il critico letterario francese R. Barthes.
La semiologia richiama l'attenzione sulla stratificazione dei significati che possono essere realizzati in una semplice raccolta di immagini. Barthes credeva che i segni comunichino significati nascosti e manifesti, esprimendo valori morali e risvegliando sentimenti o atteggiamenti nello spettatore. Pertanto, i segni costituiscono codici di comunicazione complessi. La complessità, in particolare, è dovuta al processo che ha ricevuto il nome da K. Levi-Strauss "bricolage" - la trasformazione del significato di oggetti o simboli attraverso un nuovo uso o alterazioni non standard di cose non correlate. L'autore stesso ha usato questo termine in relazione alla pratica di creare cose da qualsiasi materiale che gli capitasse: la struttura e il risultato erano più importanti delle parti costitutive che cambiano durante il processo di creazione.
N. Khomsky, un teorico e linguista americano, occupa un posto di rilievo nel campo della metodologia del linguaggio. Il più grande contributo teorico di Chomsky è stato lo sviluppo di una grammatica trasformazionale. Ogni frase contiene informazioni "strutturali profonde" insieme a una serie di "strutture superficiali". Nella sua teoria della grammatica trasformazionale, Chomsky distingue tra il significato di un messaggio (struttura profonda) e la forma in cui è espresso (struttura superficiale).
Chomsky identifica le componenti fonologiche e semantiche che si esprimono nel problema della "competenza e prestazione", che è associato alla differenza tra la capacità di usare il linguaggio (competenza) e il discorso effettivamente parlato (prestazione). "Competenza" descrive in modo più specifico le conoscenze linguistiche e grammaticali richieste per comprendere il parlato nella propria lingua, mentre "performance" descrive il modo specifico in cui viene pronunciato il discorso.
Secondo Chomsky, la competenza linguistica in una persona è innata ed è espressa negli universali della struttura grammaticale profonda. La prova dell'innatezza delle strutture grammaticali fondamentali è la velocità e l'accuratezza con cui i bambini padroneggiano le strutture della lingua. Di conseguenza, le persone hanno una predisposizione innata a comprendere le relazioni grammaticali, a estrarre "regole" dalla lingua che ascoltano e quindi ad applicarle per formare le proprie espressioni. L'approccio sociolinguistico è essenziale per le teorie della comunicazione. La sociolinguistica comprende il campo di ricerca sotto la giurisdizione della sociologia e della psicologia e relativo agli aspetti sociali e culturali nonché alle funzioni del linguaggio. Nella sociolinguistica moderna, quando si analizzano fenomeni e processi linguistici, l'enfasi principale è sul ruolo della società: viene studiata l'influenza di vari fattori sociali sull'interazione delle lingue, il sistema di una particolare lingua e il suo funzionamento. L'area disciplinare della sociolinguistica comprende oggetti, se considerati, si verifica una combinazione organica di categorie sociologiche e linguistiche. Le lingue in un paese multinazionale e le forme di esistenza di una lingua nazionale (la totalità della lingua letteraria, dialetti territoriali, socioletti-gerghi, argo) in un paese monoetnico costituiscono un sistema gerarchico chiamato "situazione linguistica".
La situazione linguistica nel suo complesso e il carico funzionale delle sue componenti dipendono dalla posizione nella società detenuta dalla comunità sociale o etnica che le parla. Durante sviluppo sociale, soprattutto con i cambiamenti socio-politici cardinali, la posizione di queste comunità sta cambiando e diventa necessario adeguare la loro nuova posizione al carico funzionale delle formazioni linguistiche.
Il processo di scelta dell'educazione linguistica per determinati scopi di comunicazione appartiene alla competenza della politica linguistica, che è definita come un insieme di misure adottate per cambiare o preservare la situazione linguistica, per introdurre nuove o consolidare le norme linguistiche esistenti, ad es. la politica linguistica include i processi di standardizzazione, codificazione di norme letterarie, creazione consapevole di parole e termini.
I rappresentanti della scuola linguistica di Kazan hanno pagato grande attenzione la definizione della linguistica come scienza e la definizione del suo posto rispetto ad altre scienze. La linguistica è stata riconosciuta come scienza indipendente, che esplora la vita del linguaggio, generalizza i fatti e determina le leggi dello sviluppo del linguaggio. La linguistica non deve essere confusa né con la filologia né con la psicologia. L'oggetto dello studio della linguistica sono lingue vive e monumenti scritti.
La linguistica come scienza è divisa in due sezioni:
IO. Pulito - linguistica teorica, che esplora:
Ø lingue già stabilite ( linguistica positiva);
Ø la questione dell'inizio della parola e le leggi generali dell'esistenza delle lingue;
II. Applicato - applica i dati della linguistica pura a domande nel campo delle altre scienze.
IN linguistica positiva Baudouin de Cortune ha distinto due sezioni:
(1) grammatica -questa è una considerazione della struttura e della composizione della lingua; tre parti della grammatica: fonetica (o fonologia), morfologia (o formazione delle parole), sintassi (o frase) .
(2) tassonomia - è una classificazione delle lingue. Ivan Alexandrovich classifica le lingue secondo principi genetici e morfologici. Genetico classificazioneprocede dal concetto di lingue correlate, ad es. lingue che hanno avuto origine dalla stessa proto-lingua, ma si sono sviluppate sotto l'influenza di condizioni diverse. Morfologicoclassificazione in base alla morfologia. Lo scienziato divide le lingue in primarioe secondario (sintetico e analitico). IN primario (sintetico)le lingue, i significati grammaticali sono espressi all'interno della parola stessa (utilizzando affissi, inflessioni); per secondario Le lingue (analitiche) sono caratterizzate dall'espressione del significato grammaticale al di fuori della parola, cioè separatamente da essa, ad esempio con l'aiuto di articoli, parole ausiliarie.
Una fonte: Il libro di testo di Kodukhov "Linguistica generale", il mio rapporto su Baudouin de Courtenay J
8. Scuola linguistica di Mosca.
La MLS è stata costituita presso l'Università di Mosca negli anni 1880 e 1890. Il fondatore dell'ILSh è Philip Fedorovich Fortunatov (1848-1914). Le sue opere principali: "Sullo stress e la longitudine nelle lingue baltiche", "Sull'insegnamento della grammatica russa nella scuola secondaria", "Lezioni sulla fonetica dell'antico slavo ecclesiastico", "Linguistica comparata".
Gli studenti ei successori delle tradizioni scientifiche di Fortunatov lo erano AA. Scacchi e A.M. Peshkovsky... Molti dei principali linguisti uscirono dalla Scuola di Medicina di Mosca: N.F. Yakovlev, G.O. Vinokur, P.S. Kuznetsov, A.A. Reformatsky, A.I. Smirnitsky e molti altri, nonché N.F. Yakovlev, N.F. Trubetskoy e R. Jacobson.
I rappresentanti dell'YLS erano comparativisti e storici della lingua, svilupparono la teoria della grammatica moderna, parteciparono alla compilazione di dizionari, allo sviluppo delle regole di ortografia e punteggiatura e allo sviluppo di metodi per insegnare la lingua russa a scuola. Paphos MLS - in protesta contro il mescolare grammatica con psicologia e logica.
Si chiama MLS. a volte "formale", perché si opponeva alla psicologia dei giovani grammatici con la necessità di cercare la propria. criteri linguistici "formali" nello studio della lingua per tutti i settori della linguistica.
ILSh si è formato durante il dominio dell'approccio storico e della giovane grammatica. Rendendo omaggio a queste idee, Fortunatov è andato oltre la struttura dei giovani concetti grammaticali e l'approccio storico in generale. Conosceva bene la matematica e si batteva per la precisione matematica nei suoi studi linguistici. Se la maggior parte dei linguisti del 19 ° secolo. Gravitato a considerare la lingua in categorie logiche o psicologiche, Fortunatov si caratterizzò poi per il desiderio di studiare la lingua, procedendo da criteri linguistici propri e, se possibile, senza riferirsi alle categorie di altre scienze. I suoi interessi di ricerca si sono concentrati principalmente nel campo della teoria grammaticale, dove ha cercato di identificare le leggi generali della struttura grammaticale, non legate allo sviluppo storico. Fortunatov era anche impegnato nella tipologia, confrontando la struttura delle lingue, indipendentemente dalla loro storia e dai legami familiari. Gli alunni di Fortunatov hanno mantenuto approcci simili; alcuni di loro, in particolare Durnovo, in seguito si sono rivolti direttamente ai metodi strutturali.
Senza abbandonare la ricerca storica storica e comparativa, i rappresentanti della scuola Fortunatov erano impegnati nello studio sincrono delle lingue, in particolare di quelle moderne. L'area della loro ricerca speciale era la grammatica, in seguito anche la fonologia. Un ruolo significativo nella formazione e nello sviluppo delle idee della scuola è stato svolto dalle attività della Commissione dialettologica di Mosca (1904-1931), che ha avviato uno studio attivo dei dialetti russo, ucraino e bielorusso.
Particolarmente significativo è il contributo della MLS alla creazione dell'insegnamento moderno sulla forma di una parola e sulle classi grammaticali di parole, sulla forma di una frase e sulle frasi grammaticali e sui suoi vari tipi.
La dottrina della forma della parola è centrale per la teoria grammaticale della MLS. Forma verbale (forma verbale), secondo la definizione di Fortunatov, - è una radice di parola e un affisso formativo.
La questione delle parti del discorso... Come sapete, le parti del discorso sono divise in significative, servizio e interiezioni. Fondamentalmente nuovo nell'insegnamento della MLS era classificazione formale di parole complete , vale a dire: dividendoli in parole con forme di cambiamento(parole formali complete) e senza forme di flessione (parole intere informe). Alla classe parole senza forma inclusi non solo avverbi e gerundi, ma anche infiniti, sostantivi e aggettivi non declinanti, nonché particelle, preposizioni, congiunzioni e interiezioni.
Teoria sintattica La MLS includeva due aspetti: la dottrina della frase e la dottrina della frase:
1) Collocazione È la combinazione di parole nel pensiero e nel discorso. Le collocazioni formano forme di parole sintattiche e ordine delle parole. Sintattiche sono quelle forme di parole che denotano la dipendenza di alcune parole da altre. Le categorie sintattiche in russo, ad esempio, sono le categorie di caso e numero di nomi; persona, numero, genere, tempo e umore del verbo, ecc. Forme di categorie sintattiche, che collegano le parole nel discorso, esprimono relazioni grammaticali formali. A questo proposito, sono stati distinti vari tipi di connessioni nella frase: composizione, inclusione (che si divide in gestione, coordinamento e adiacenza) e subordinazione.
2) Quando le parti grammaticali di una frase differiscono come predicato grammaticale e soggetto grammaticale, essa (cioè la frase) si forma frase... Di conseguenza, la frase come forma di linguaggio è definita attraverso la forma di predicato. Peshkovsky e Shakhmatov svilupparono l'insegnamento grammaticale formale di Fortunatov sulla proposta. Collegavano la teoria della frase con la dottrina della base della frase.
ILSh si è sviluppato in polemica sia con i rappresentanti del vecchio approccio storico, sia con la scuola linguistica di Pietroburgo di Baudouin de Courtenay e L.V. Shcherba. Gli oppositori spesso rimproveravano ai linguisti della scuola Fortunatov il "formalismo" e i suoi stessi rappresentanti riconoscevano la priorità della forma nell'analisi linguistica. Un esempio della divergenza di posizioni tra le due scuole è la disputa su parti del discorso. Successivamente, le differenze teoriche tra le scuole trovarono espressione nelle controversie tra le scuole fonologiche di Mosca e di Leningrado.
L'emergere dello strutturalismo, in un modo o nell'altro, fu percepito da molti rappresentanti della scuola Fortunatov, in particolare quelli appartenenti alla sua terza generazione, e Trubetskoy e Jakobson, che ne uscirono, giocarono un ruolo significativo nell'emergere e nelle attività del Circolo linguistico di Praga; Jacobson in seguito influenzò lo sviluppo dello strutturalismo americano. In particolare, è stato nella Scuola di Economia di Mosca (Yakovlev, Trubetskoy) che il concetto di fonema, originariamente sviluppato nella scuola linguistica di San Pietroburgo ed era assente da Fortunatov e dai suoi allievi immediati, è stato ripensato sulla base del rifiuto dello psicologismo e dello sviluppo di criteri strettamente linguistici per l'identificazione dei fonemi; Successivamente, grazie agli sforzi di Jacobson e Trubetskoy, questo approccio ha assunto una posizione dominante nella linguistica mondiale.
Una fonte: Il libro di testo di Kodukhov "Linguistica generale"
9. F. de Saussure e il suo corso di linguistica generale.
Ferdinand de Saussure (1857-1913) Linguista svizzero, che pose le basi della semiologia e della linguistica strutturale, che si trovava alle origini della Scuola linguistica di Ginevra. Le idee di Ferdinand de Saussure, che è spesso chiamato il "padre" della linguistica del XX secolo, hanno avuto un impatto significativo sul pensiero umanitario del XX secolo in generale, ispirando la nascita dello strutturalismo.
F. de Saussure ha insegnato linguistica generale, prima a Parigi e poi a Ginevra. Sulla base delle registrazioni delle sue lezioni effettuate dagli studenti dai colleghi più giovani di Saussure - C.Balli e A. Sechet, è stato preparato e pubblicato un libro "Corso di Linguistica Generale" nel 1916, ad es. dopo la morte di Saussure. Così, lo stesso Saussure non è riuscito a conoscere il significato mondiale delle sue idee, che non intendeva pubblicare durante la sua vita e non ha nemmeno avuto il tempo di esporre costantemente sulla carta. Bally e Seschet possono, in una certa misura, essere considerati coautori di questo lavoro, dal momento che Saussure non aveva intenzione di pubblicare un libro del genere, e gran parte della sua composizione e del suo contenuto sembra essere stata introdotta dagli editori (molto non è negli appunti di Saussure, sebbene, ovviamente, potrebbe condividere idee con i colleghi in conversazioni private). Il libro "Corso di linguistica generale" ha segnato l'inizio di una nuova fase nello sviluppo della scienza mondiale del linguaggio. È significativo che in un primo momento alcune disposizioni del Corso siano state percepite, e dopo alcuni anni hanno dato origine a nuovi approcci al linguaggio: sociale, strutturale-sistemico, sincrono-moderno, ecc.
Le principali disposizioni del "Corso di Linguistica Generale":
1) L'argomento della linguistica come scienza è il linguaggio... Ne consegue che la lingua dovrebbe essere studiata in una scienza indipendente e non essere alternativamente un oggetto di psicologia, fisiologia o sociologia. La linguistica stessa dovrebbe considerare lo studio della lingua come la sua materia (oggetto) più importante e non condividere questa responsabilità con nessun'altra scienza.
2) F. de Saussure ha distinto tra i concetti di linguaggio e discorso... La lingua è un sistema di elementi e regole; la lingua si riferisce alla società nel suo insieme (cioè la lingua è sociale). Il discorso è un'implementazione individuale di una lingua.
3) F. de Saussure ha definito il linguaggio come sistema di segniesprimere concetti... A questo proposito, Saussure ha chiamato linguistica semiologico scienza (più tardi il termine semiotica), interpretandola come la scienza del sistema dei segni del linguaggio.
4) Segno di lingua consiste di significante (immagine acustica) e significato (concetto). Un segno linguistico ha due proprietà principali:
Ø l'arbitrarietà della connessione tra il significante e il significato, cioè in assenza di una connessione interna, naturale tra loro;
Il significante Ø ha estensione in una dimensione (nel tempo).
Il segno linguistico può cambiare: in questo caso, c'è uno spostamento nel rapporto tra significato e significante. Questa posizione è collegata ad un'altra famosa posizione del "Corso di Linguistica Generale" - sincronicità opposta e diacronia .
F. de Saussure ha individuato due assi:
Ø asse di simultaneitàsu cui si collocano fenomeni coesistenti nel tempo;
Ø asse di sequenza,su cui ogni fenomeno si trova nello sviluppo storico con tutti i cambiamenti.
La presenza di questi due assi serve, secondo Saussure, la differenza tra le due linguistiche: sincronico (collegato all'asse simultaneità) e diacronico (collegato all'asse sequenze).
Linguistica diacronica esplora la relazione tra elementi mutevoli e sequenziali nel tempo, ad es. infatti è una diretta continuazione degli insegnamenti dei giovani grammatici Tuttavia, Saussure sottolinea la necessità di distinguere tra linguistica diacronica promettente (che riflette la storia della lingua in conformità con l'effettivo sviluppo degli eventi) e retrospettiva (che si occupa della ricostruzione delle forme del linguaggio). Ma la linguistica diacronica non spiega l'organismo interno di una lingua come sistema, è l'argomento della linguistica principale - sincronico.
Linguistica sincrona è una teoria dello stato del linguaggio. La posizione centrale della linguistica sincronica sono le disposizioni in materia segno di lingua (vedi sopra), rilevanza linguistica e teoria dei sintagmi e delle associazioni.
Significato linguistico è una connessione nel sistema del linguaggio del significato e del significante.
Sintagma e teoria delle associazioni ... F. de Saussure ha identificato due tipi di relazioni: sintagmaticoe associativo. Relazioni sintagmatiche basato sulla natura lineare della lingua; queste sono relazioni, elementi che si costruiscono uno dopo l'altro nel flusso della parola. Relazioni associative fare affidamento sulla connessione dei segni nella comprensione di chi parla, ad esempio: scrivi - scrivi - riscrivi o scrivi - disegna - attacca... Le serie associative, a differenza dei sintagmi, esistono potenzialmente, la loro composizione può essere diversa.
Quindi, il risultato principale del "Corso di linguistica generale" è stata la distinzione tra lingua e parola, sincronicità e diacronia. Queste distinzioni hanno permesso di distinguere una disciplina relativamente ristretta con determinati confini: linguistica sincrona ... I suoi problemi erano limitati a una domanda specifica: come funziona la lingua? (cioè le domande sono passate in secondo piano: come si sviluppa la lingua? e come funziona la lingua?). La limitazione della materia ha permesso, all'interno di questo ristretto quadro, di elevare la teoria e la metodologia della linguistica a un livello superiore.
Il nome di F. de Saussure è associato alle attività di due scuole linguistiche: Ginevra e Parigi. PER Ginevra appartenere Seshe, Bally, Kartsevsky, Godel... PER La Parigi – Meillet, Vandries, Grammon e Cohen.
Una fonte
10. L'emergere di nuove tendenze nella linguistica all'inizio del XX secolo.
L'emergere di nuove tendenze nella linguistica è associato alla pubblicazione del "Corso di linguistica generale" di F. de Saussure (1916) e alla decodifica del cuneiforme ittita da parte di B. Grozny (1917). "Corso" Saussureda un lato, ha liberato la linguistica dalle interferenze di fisiologia, psicologia, sociologia e altre scienze con posizioni estranee al linguaggio; Lavoro B. Grozny "La lingua ittita, la sua struttura e appartenenza alla famiglia delle lingue indoeuropee", d'altra parte, suscitò tutta l'indo-propistica, aprì nuovi orizzonti per esso.
Le nuove direzioni della linguistica all'inizio del XX secolo includono quanto segue:
(1) Sociolinguistica.
L'affermazione dell'idea di Saussure dell'opposizione del linguaggio (come fenomeno sociale) e della parola (come manifestazione di un'essenza psichica individuale) ha fatto emergere all'inizio del XX secolo la "linguistica sociologica" (Meillet, Vandries, Sesche, Balli).
La particolarità del linguaggio è che si tratta di un sistema di segni di un tipo speciale: questi segni sono usati in un dato momento dai membri di una data società e vengono trasmessi alle generazioni future.
All'inizio, la linguistica sociologica era sotto l'influenza della "psicologia sociale" e quindi non poteva diventare veramente scientifica. Chiarisce solo i suoi problemi e si sviluppa o come insegnamento sulla differenziazione sociale delle lingue, o come insegnamento sulla norma del linguaggio, o come focus su questioni etno e psicolinguistiche.
(2) Strutturalismo.
L'emergere dello strutturalismo risale al 1926, la data di fondazione del Circolo Linguistico di Praga. Entro la metà del 20 ° secolo, diverse direzioni dello strutturalismo hanno preso forma in diversi paesi. Hanno ricevuto designazioni da paesi secondo i loro principi teorici: strutturalismo di Praga (linguistica funzionale), strutturalismo di Copenaghen (glossmatica), strutturalismo americano (linguistica descrittiva); le loro versioni di strutturalismo apparvero in Svizzera (Ginevra), Inghilterra (Londra), nell'URSS ( Apresyan Yu.D. "Idee e metodi della linguistica strutturale moderna" 1966)
Lo strutturalismo è nato come continuazione del neogrammatismo, come negazione del grammaticale giovane con la sua attenzione alla storia del linguaggio, come negazione delle tendenze psicologiche e socio-psicologiche. Possiamo dire che la linguistica strutturale si è concentrata sullo studio di un solo problema: Come funziona la lingua? In quest'area della scienza ha dato un contributo indiscutibile. I problemi Come si sviluppa la lingua? e Come funziona la lingua? non erano priorità per lei.
Comune al lavoro strutturale è il riconoscimento dei seguenti postulati:
a) la lingua è iconico (semiotico) sistema;
b) si concentra sull'apprendimento sincronicità, cioè fenomeni associati al modello del linguaggio moderno;
c) La principale area di sviluppo dei metodi per la linguistica strutturale era fonologia; in misura minore gli strutturalisti si occupavano della morfologia e ancor meno della sintassi.
d) Gli strutturalisti si battono per un'analisi rigorosa e precisa dei fatti, spesso utilizzando metodi matematici;
e) gli strutturalisti sono alla ricerca di metodi di ricerca linguistica adeguati senza fare affidamento su dati di altre scienze: sociologia, psicologia, logica, ecc.
(3) Neolinguistica.
Le origini della neolinguistica nelle opere degli studenti di Schleicher - G. Schuhardte I. Schmidtche ha inventato la teoria dell '"allineamento geografico" delle lingue. Questa teoria spiega le somiglianze tra le lingue in base al fattore spaziale e geografico. I continui movimenti dei popoli portano allo scambio di vocaboli tra le lingue in contatto e ad una più profonda confusione. Lo stesso concetto è proiettato nel passato indoeuropeo. L'immagine dell '"albero delle lingue" è stata sostituita da idee sulla somiglianza delle lingue nella coesistenza. Nel tempo, la neolinguistica si è sviluppata in linguistica areale.
(4) Grammatica generativa.
Emergenza grammatica generativa associato alle opere di un linguista americano N. Chomsky "Strutture sintattiche", Aspetti della teoria della sintassi ", che ha proposto negli anni '50 -'60 una descrizione del linguaggio secondo modelli formali. Secondo Chomsky, questa grammatica è progettata per stabilire le regole in base alle quali i parlanti generano frasi. Nel creare la sua grammatica, Chomsky è partito dal presupposto che la competenza linguistica sarà suddivisa in competenza (cioè conoscenza dell'insieme di regole con cui vengono costruite le frasi) e utilizzando (cioè la capacità di tenere conto di fattori extra-linguistici quando si costruisce una frase, ad esempio: la situazione, lo stile di discorso dell'interlocutore, ecc.). Tuttavia, la grammatica generativa di Chomsky si occupava principalmente di linguistica competenza e in piccola misura - condizioni situazionali uso linguaggio. Tuttavia, il sistema di descrizione del linguaggio creato da Chomsky ha svolto un certo ruolo nello sviluppo della linguistica.
Una fonte: Khrolenko, Bondaletov "Teoria del linguaggio" / libro di testo.
11. Linguistica funzionale del Circolo di Praga.
Il Circolo Linguistico di Praga è stato fondato nel 1926 da un filologo cecoslovacco V. Mathesius... Il "nucleo russo" del cerchio era Jacobson, Trubetskoy, Kartsevsky.
Il predecessore ideologico del Circolo di Praga è F. de Saussure, il cui nome è associato all'idea di linguaggio come caso particolare di sistemi semiotici (di segni). Il circolo praghese fu influenzato anche dalla tradizione linguistica russa, in particolare dalle idee di Fortunatov, Shcherba e soprattutto I. A. Baudouin de Courtenay.
Nel documento del programma del popolo di Praga "Abstracts del Circolo Linguistico di Praga" (1929) ha avanzato due principali principi metodologici: funzionale e strutturale. Strutturale basato sulle idee di Saussure sulla distinzione tra linguaggio e discorso, sincronia e diacronia; ha unito il popolo di Praga con altri rami dello strutturalismo. Funzionale, per molti versi ascendente a Baudouin de Courtenay, era specifico per il popolo di Praga, nelle Tesi fu messo al primo posto.
L'idea principale dei rappresentanti del circolo di Praga è comprensione del linguaggio come sistema funzionale. Funzione chiamato il compito, l'obiettivo dell'attività vocale. Pertanto, l'analisi linguistica deve essere affrontata da un punto di vista funzionale. Le tesi evidenziano le principali funzioni della lingua. Attività vocale in ruolo sociale ha entrambi funzione comunicazione o poetico funzione... La componente specifica di Praga della classificazione - evidenziando la funzione poetica... Se per altre scuole di poetica dello strutturalismo, lo studio del discorso artistico era al di fuori delle problematiche linguistiche, allora il popolo di Praga ha dato un contributo significativo a quest'area. A questo proposito, il popolo di Praga ha affrontato i problemi della lingua letteraria. Il risultato dell'approccio funzionale alle lingue letterarie è stato lo sviluppo di una disciplina linguistica speciale: la storia delle lingue letterarie.
Le tesi riflettevano anche le idee del popolo praghese riguardo alla storia della lingua. Il circolo di Praga, accettando la distinzione di Saussure tra sincronicità e diacronia e dando incondizionatamente la priorità alla sincronicità, non considerava questa distinzione assoluta. A differenza dei glossmatici, i Praziani consideravano sincronia non come sistema in completa astrazione dal tempo, ma come stato del linguaggio in uno dei momenti del suo sviluppo.
Il merito indiscusso del Prague Circle è la creazione fonologia ... La fonologia è descritta nel modo più completo nel libro Nikolai Sergeevich Trubetskoy "Fondamenti di fonologia" (1939). Trubetskoy distingue tra due scienze: fonetica (insegnando i suoni della parola) e fonologia (insegnamento sui suoni della lingua). Un fonema è l'unità fonologica più breve di una lingua; i suoni sono simboli materiali dei fonemi. Per evidenziare il fonema, Trubetskoy ha introdotto un concetto che è fondamentale nel suo significato opposizione ... L'opposizione spicca multidimensionale (comprese più di due unità), unidimensionale (specifico solo per questa coppia di unità), proporzionale (le stesse opposizioni avvengono per più coppie) e isolato (questa opposizione non si trova da nessun'altra parte). Un'importante distinzione tra opposizioni è legata alla differenza permanente e neutralizzato opposizioni. Permanente le opposizioni persistono in tutte le situazioni. Neutralizzato le opposizioni persistono in alcuni casi e si realizzano in altri, ad esempio, in lingua russa, l'opposizione di sordità e assenza di voce viene neutralizzata alla fine di una parola fonetica. A questo proposito, viene introdotto il concetto arcifonemi , cioè un insieme di caratteristiche significative di due fonemi (ad esempio, molti co [s] contiene un arcifonema).
Problemi morfologici Il circolo di Praga si limitava allo studio dei morfemi e delle opposizioni morfologiche (ad esempio l'opposizione dei tempi verbali), la neutralizzazione delle opposizioni (ad esempio, la neutralizzazione dei generi in una pluralità), la totalità delle opposizioni. Quindi, un sostantivo in russo è inteso come la capacità di una parola appartenente a questa parte del discorso di partecipare all'opposizione di casi, numeri e genere.
La dottrina di Matesius divenne molto famosa sull'attuale divisione della proposta... Se nella divisione formale (logico-grammaticale) gli elementi principali sono il soggetto grammaticale e il predicato grammaticale, allora durante la divisione effettiva vengono rivelate la base e il nucleo dell'enunciato ("tema" e "rhema").
Quindi, i principali risultati della direzione dello strutturalismo di Praga sono:
(1) la distinzione tra il linguaggio ordinario e il linguaggio del poetico;
(2) insegnamento della lingua letteraria e dei suoi nomi;
(3) sviluppo della dottrina del fonema - la sua definizione, descrizione delle caratteristiche differenziali, opposizioni, neutralizzazione (Trubetskoy);
(4) Trubetskoy, oltre ai concetti esistenti di "famiglia di lingue" e "ramo di lingue", introduce il concetto " unione linguistica», Indicando loro la somiglianza delle lingue causata dalla vicinanza del luogo e dagli stretti contatti dei loro parlanti (Baltic Language Union);
(5) Gli abitanti di Praga furono i fondatori della dottrina dell'effettiva divisione della pena.
Una fonte: Alpatov "Storia delle dottrine linguistiche", il libro di testo di Kodukhov "Linguistica generale"
12. Linguistica descrittiva americana.
Linguistica descrittiva - la direzione principale della linguistica americana negli anni 20-50. XX secolo (dall'inglese. descrittivo - descrittivo), uno dei rami della linguistica strutturale. Il fondatore del descrittivismo è stato Leonard Bloomfield, altri rappresentanti di spicco sono stati: Z. Harris, B. Blok ecc. Idee e metodi di questa direzione si riflettono nel libro Bloomfield "Lingua" e nel tutorial G. Gleason "Introduzione alla linguistica descrittiva" .
La nascita della linguistica descrittiva associato allo studio delle lingue degli indiani d'America... Inoltre, molto di ciò che era consuetudine per la linguistica tradizionale si è rivelato inadatto a questo scopo.
All'inizio, per tutto il XIX secolo, la linguistica si sviluppò come scienza storica e le lingue indiane, come talvolta si diceva, "non avevano storia". Naturalmente, queste lingue avevano una storia, ma non c'erano dati al riguardo, perché le lingue indiane non avevano una lingua scritta. Pertanto, lo studio sincrono di queste lingue era in primo piano (cioè la diacronia non era applicabile alle lingue indiane).
In secondo luogo, quando si descriveva una lingua indiana, è sorta una domanda che non era molto rilevante per uno specialista in lingue europee: come evidenziare le parole in questa lingua? La linguistica tradizionale non aveva un metodo chiaramente sviluppato per dividere il testo in parole. Nella maggior parte dei casi, questa divisione era basata sull'intuizione di madrelingua. Tuttavia, quando ci si riferisce alle lingue indiane troppo lontane dalle lingue europee, è diventato necessario sviluppare criteri rigorosi per la selezione delle parole.
Era ancora più difficile con la semantica grammaticale e lessicale. Le categorie grammaticali delle lingue indiane non significano affatto ciò che è stato stabilito dalla scienza europea, ma per diverse parole completamente non sinonimi in inglese una parola della lingua indiana può corrispondere.
Alla fine, un madrelingua di una lingua incomprensibile ha iniziato a svolgere un ruolo speciale: informatore... Nel processo di studio, ho dovuto fare domande al madrelingua della lingua di destinazione, che di solito parlava anche inglese.
Tutte queste caratteristiche hanno contribuito al rafforzamento della tendenza generale a considerare il linguaggio come un fenomeno completamente esterno al ricercatore. I descrittivisti cercarono di studiare il loro oggetto sulla base dei soli metodi linguistici, senza ricorrere all'aiuto di altre scienze. La cosa principale per i descrittivisti era lo sviluppo di un metodo per descrivere linguaggi specifici (da cui il nome).
La tecnica di analisi del testo nella linguistica descrittiva è caratterizzata da tre fasi: 1 ° stadio - dividere il testo in segmenti minimi (fonemi, morfemi); mentre l'unità prioritaria è morfema , e non una parola (poiché è più difficile cedere a un'analisi formale rigorosa); 2 ° stadio - con aiuto analisi distributiva scopri cosa può essere considerato due unità diverse e cosa - una e la stessa; 3 ° stadio - costruzione di qualche modello del linguaggio a un dato livello della sua struttura.
I descrittivisti si occupavano prevalentemente di fonologiae morfologia... Hanno considerato la differenza tra fonologia e morfologia puramente quantitativa: ci sono più morfemi che fonemi e sono più lunghi, ma non c'è differenza fondamentale tra loro.
Concetto morfemi , introdotto nella linguistica da Baudouin de Courtenay, divenne una delle lingue centrali nel sistema di Bloomfield. Se tradizionalmente le radici e gli affissi erano considerati come parti di una parola e come unità definite attraverso una parola, allora Bloomfield definisce un morfema e una parola indipendentemente l'uno dall'altro, attraverso il concetto primario forma (forma - qualsiasi segmento audio ripetitivo che abbia un significato). Poi morfema - forma minimale, parola- la forma minima che può essere una dichiarazione. Bloomfield ha introdotto il concetto sememes È l'unità di valore minima corrispondente al morfema.
L'approccio di Bloomfield alla definizione del morfema ha aperto la strada alla trasformazione della morfologia in morfemi. Se la morfologia tradizionale proveniva dalla parola come dall'unità psicologicamente più significativa, allora la morfologia descrittiva veniva dal morfema. Allo stesso tempo, in primo luogo, il movimento è passato da unità più piccole alle loro sequenze e, in secondo luogo, il morfema nel senso di Bloomfield si è rivelato universale per qualsiasi lingua.
Nella linguistica descrittiva, insegnamento sui diversi tipi di distribuzione... La cosa più importante è l'opposizione distribuzione contrastante - non contrastante . Distribuzione contrastante (in cui gli elementi, quando scambiati, agiscono da discriminatori di significato) caratterizza le unità indipendenti della struttura del linguaggio (invarianti) a qualsiasi livello. Distribuzione non contrastante (variazione libera e distribuzione aggiuntiva) è inerente alle varianti di un'unità. I descrittivisti riconoscevano la possibilità teorica di costruire una descrizione completa di una lingua unicamente sulla base dei dati sulla distribuzione delle sue forme. A questo proposito, la linguistica descrittiva è spesso chiamata linguistica distributiva.
Sintassi molti descrittivisti lo consideravano una semplice estensione della morfologia. Proprio come tutto in un morfema era considerato riducibile ai suoi fonemi costituenti, le parole e le costruzioni erano considerate possibili da descrivere attraverso i loro morfemi costituenti e le classi di morfemi. La struttura di un'enunciazione è descritta in termini di classi di morfemi (o parole), è rappresentata sotto forma di un modello lineare: una catena di core + aggiunte (cioè accompagnamento), è riconosciuto il parallelismo dell'analisi di qualsiasi forma complessa, sia morfologica che sintattica. Tuttavia, il più diffuso nella ricerca sintattica descrittiva è stato metodo di analisi diretta.
Fin dal suo inizio, la linguistica descrittiva non è stata un corso uniforme. Il desiderio di una sempre maggiore formalizzazione è caratterizzato da un gruppo di studenti e seguaci di Bloomfield alla Yale University, il cosiddetto scuola di yale (B. Block, J.L. Traiger, Harris, Hockett, ecc.). Al contrario, il cosiddetto ann arbor school (Michigan University) si distingue per una più ampia gamma di problemi, esplora i significati, le connessioni del linguaggio con la cultura e l'ambiente sociale, fondendosi con l'etnolinguistica (Freese, K.L. Pike, Naida, ecc.).
Una comprensione semplificata della lingua, la portata limitata dei problemi, l'assolutizzazione dell'aspetto distributivo della lingua hanno già portato alla fine. Anni '50 - primi. Anni '60 alla crisi della linguistica descrittiva e alla perdita di una posizione di leadership nella scienza americana.
Una fonte: Alpatov "Storia delle dottrine linguistiche", libro di testo di Kodukhov "Linguistica generale", Dizionario enciclopedico linguistico
13. Strutturalismo di Copenaghen (glossmatica).
GLOSSEMATICS (dal greco. Glssа - lingua) è una teoria linguistica che è diventata la manifestazione più coerente dello strutturalismo nella linguistica dell'Europa occidentale. Sviluppato negli anni 30-50. Louis Elmslev e (in parte) altri membri del Circolo Linguistico di Copenaghen. Il nome "glossmatica" è stato scelto per sottolineare la differenza fondamentale tra questa teoria e la linguistica tradizionale.
La principale fonte metodologica della glossmatica per comprendere la natura del linguaggio è linguistica gli insegnamenti di F. de Saussure... La glossematica ha tratto dall'insegnamento di Saussure sulla lingua:
ü l'idea di distinguere tra linguaggio e discorso,
ü comprensione del linguaggio come sistema di segni e comprensione di un segno come unità del significante e del significato,
ü la disposizione che la lingua è una forma, e anche che da un punto di vista linguistico, la lingua dovrebbe essere considerata in sé e per sé.
Oltre al concetto di Saussure, la glossmatica è stata significativamente influenzata da un'importante direzione filosofica di quegli anni - neopositivismo... I neopositivisti hanno ridotto i problemi filosofici all'analisi logica. Erano interessati alle regole formali per costruire una teoria scientifica in astrazione dal modo in cui questa teoria si relaziona alla realtà.
Il compito che Yelmslev si pone è quello di costruire una teoria generale del linguaggio. Ha rifiutato l'approccio induttivo basato sulla descrizione di fatti linguistici; non è interessato a fatti particolari, caratteristiche di linguaggi specifici. La teoria dovrebbe essere il più generale possibile e basata sui principi più generali presi dalla logica matematica. Poiché gli oggetti della teoria linguistica sono testi, l'obiettivo della teoria linguistica di Yelmslev è quello di creare un metodo universale mediante il quale un dato testo può essere compreso. Propone tre requisiti fondamentali per una descrizione glossmatica di una lingua: coerenza, esaurimento e semplicità di descrizione.
Elmslev considerava la glossmatica una teoria deduttiva generale del linguaggio, applicabile a qualsiasi lingua specifica, esistente o solo possibile. Pertanto, sono state date le caratteristiche caratteristiche delle teorie matematiche. L'analisi dei fatti del linguaggio nella glossmatica si distingue per un grado estremo di astrattezza e formalismo.
Inoltre, la glossmatica evidenzia i concetti di base associati all'analisi del linguaggio. Cerca di rendere questi concetti il \u200b\u200bpiù generali possibile, adatti a un'ampia varietà di casi. Se la linguistica tradizionale descriveva ogni livello linguistico in termini speciali, Elmslev propone i concetti più generali presi dalla matematica: si tratta di oggetti, classi di oggetti, funzioni o dipendenze (tra variabili, costanti, ecc.)
Il linguaggio era inteso nella glossmatica, così come in altre direzioni dello strutturalismo, come un sistema di segni, tuttavia, la comprensione di un segno è molto peculiare qui. Seguendo Saussure, Elmslev procedette dalla bilateralità del segno ("significante" e "significato"), ma propose i suoi termini - " piano di espressione " e "Piano dei contenuti" che in seguito si diffuse. La glossematica distingue tra un piano di espressione e un piano di contenuto, e ai termini "espressione" e "contenuto" viene dato un significato astratto, in modo che sia consentita la possibilità di usarne uno al posto dell'altro. Si ottiene così una generalizzazione del concetto di segno, ma a costo di separare il contenuto intellettuale della lingua dalla realtà non linguistica. Sia in termini di espressione che in termini di contenuto, la forma contrapposta si distingue come principio guida nel linguaggio e nella sostanza, che è posta in assoluta dipendenza dalla forma.
La comprensione della forma come essenza principale del linguaggio, presumibilmente completamente indipendente dalla sostanza, si esprime più concretamente nella glossmatica nella riduzione del linguaggio ereditato da Saussure a un sistema di pure relazioni, qui chiamate funzioni. Gli elementi del linguaggio ("funzionali") legati da queste relazioni sono dichiarati privi di esistenza indipendente e sono riconosciuti solo come risultati dell'intersezione di fasci di relazioni. L'inappropriata esagerazione del ruolo delle relazioni a scapito del ruolo degli elementi correlati è la principale manifestazione dell'essenza idealistica della glossmatica.
Forse nessuna direzione linguistica è stata distratta dalla persona che parla in modo così coerente come la glossmatica. Criticando giustamente molte delle carenze del tradizionale approccio umanitario al linguaggio, in cui si mescolano fenomeni dissimili, lo scienziato danese ha introdotto il rigore matematico nella scienza del linguaggio, ma ciò è accaduto a causa di un restringimento e di un impoverimento molto significativi del suo oggetto.
Nonostante tutta la sua cattiveria metodologica, la glossmatica ha svolto un ruolo positivo nella storia della linguistica. Come teoria deduttiva generale del linguaggio, è stato uno dei primi tentativi di combinare la linguistica con la logica formale e quindi ha influenzato il miglioramento di metodi precisi di studio del linguaggio. Tuttavia, l'inadeguatezza pratica del glossmat
A.A. Potebnya ha contribuito allo sviluppo dello psicologismo linguistico e della linguistica storica comparata in Russia. Credeva che Humboldt "ponesse precisamente le fondamenta della questione trasferita su una base psicologica con le sue definizioni del lavoro del linguaggio come attività, il lavoro dello spirito come organo di pensiero". Sulla base del lavoro di Humboldt e Steinthal, Potebnya ha creato un concetto originale che considera il linguaggio come un fenomeno storico e un'attività di pensiero vocale.
La lingua come uno dei tipi di attività umana ha tre lati: universale, nazionale e individuale. I suoi lavori principali: "Pensiero e linguaggio", "Da Appunti sulla grammatica russa" ci rivelano le condizioni principali del concetto. L'attività vocale, secondo Potebnya, è l'interazione del linguaggio, la conoscenza di chi parla e il pensiero trasmesso, e il compito più importante del ricercatore è rivelare l'interazione tra parola e pensiero, e non le forme logiche e le forme del linguaggio. L'attività di pensiero vocale è individuale e attiva. Pertanto, è necessario conoscere non solo le categorie del linguaggio e i pensieri e le conoscenze prevalenti e già pronti, ma anche il processo stesso di espressione dei pensieri e comprensione da parte dell'ascoltatore. Il linguaggio non è solo un ricettacolo e un mezzo per trasmettere pensieri ed emozioni, ma anche un mezzo per formare pensieri nel parlante e nell'ascoltatore. Dal punto di vista del rapporto tra lingua, parola e pensiero, è importante comprendere la struttura semantica della parola e la forma e la categoria grammaticale. Potebnya ha prestato particolare attenzione alla loro ricerca.
La parola ha la funzione di generalizzare e sviluppare il pensiero. Secondo Potebnya, attraverso la parola, i pensieri vengono idealizzati e liberati dall'influenza travolgente e rilassante delle percezioni sensoriali dirette, in modo che vi sia un cambiamento di rappresentazione - immagine in rappresentazione - concetto. La parola diventa il suo simbolo. Ogni parola è composta da tre elementi: un suono articolato, rappresentazione e significato. La parola non è solo una solida unità, ma un'unità di presentazione e significato. Oltre al suono, la parola contiene anche un segno di significato, che è la forma interna della parola. Il significato del segno è già un simbolo che rappresenta le parole in un sistema in grado di trasmettere e formare pensieri e significati che non costituiscono il contenuto della parola. Per Potebnya è particolarmente importante che "la forma grammaticale è un elemento del significato di una parola ed è omogenea con il suo significato materiale". Per determinare il significato della forma grammaticale, è necessario collegarla con il resto delle forme della lingua del sistema dato, con quelle categorie generali "secondo le quali il contenuto particolare della lingua è distribuito, contemporaneamente alla sua apparizione nel pensiero".
Il discorso, come un insieme di frasi, secondo Potebnya, fa parte della lingua. La divisione della frase in parti del discorso e i membri della frase dal punto di vista della loro occorrenza e del loro ruolo nella progettazione e trasmissione del pensiero non coincidono con la sua divisione logica e grammaticale. L'articolazione del discorso è associata all'articolazione semantica di una frase basata sul giudizio psicologico (e non logico). Il giudizio psicologico è un'appercezione semantico-sintattica: "Appreso e soggetto a spiegazione è il soggetto del giudizio, apprendere e determinare è il suo predicato". Ad esempio, una frase logica formale, "Mucca e volpe". Una volpe non è l'equivalente di una mucca quando entrambe le loro articolazioni di base sono diverse. La frase non solo utilizza tutti i mezzi della lingua, ma anche l'interazione del vocabolario e della grammatica in varie categorie grammaticali: parola, parte del discorso, membro della frase e tipo di frase.
L'argomento di particolare attenzione Potebnya era la sintassi comparativa - storica delle lingue slave. Analizzando, prima di tutto, i membri costitutivi della frase e le loro sostituzioni storiche causate dal desiderio di differenziare i membri della frase, considerando due fasi storiche nello sviluppo della frase (fasi delle frasi nominali e verbali), le modalità dell'emergenza e dello sviluppo di semplici e frasi complessePotebnya ha avuto un'enorme influenza sullo sviluppo dei problemi della teoria sintattica slava e indoeuropea. Allo stesso tempo, le sue conclusioni e osservazioni avevano molto in comune con gli insegnamenti dei suoi contemporanei e successori: i giovani grammatici.
La caratteristica più caratteristica della direzione logica in linguistica è la considerazione della filosofia del linguaggio come un problema logico. La semantica linguistica è identificata con categorie e operazioni logiche e forme linguistiche - con forme logiche di pensiero.
Evidenzia lo studio universale proprietà del linguaggio, descritte utilizzando la tecnica di classificazione deduttiva.
Il logismo linguistico è una categoria in via di sviluppo storico. Se la logica di Aristotele poneva solo il problema del rapporto tra frasi e parti del discorso, la grammatica di Port-Royal enfatizzava l'universalità delle categorie logico-grammaticali. Rappresentanti della direzione logica e grammaticale dell'inizio e della metà del XIX secolo. considerato anche il rapporto principale tra logica e grammatica in linguistica: le categorie logiche si trovano in una frase e la grammatica contribuisce allo sviluppo pensiero logico... Il pensiero stesso era inteso come forme di pensiero statiche, costanti e generali. L'unità principale è la frase e la categoria sono le parti del discorso: le forme grammaticali sono i loro segni, i significati verbali (verbali, linguistici) sono conoscenze scientifiche. Il compito della grammatica è scoprire la corrispondenza delle forme linguistiche con le categorie logiche che sono numerabili. Quindi, secondo Becker, ci sono 12 elementi e 81 relazioni nella logica.
Alla fine del XIX secolo. la direzione logica si sviluppa prima come sintassi semantico-semantica, e poi come sintassi semantico-strutturale. Nella formazione di queste scuole logico-semantiche, le opere di V.A. Bogoroditsky, A.A. Shakhmatova, I.I. Meshchaninov, nonché rappresentanti della sintassi semantica, comunicativa e nominativa.
Nel XIX secolo. i concetti degli aderenti alla direzione logica sono molto cambiati grazie allo sviluppo della lessicologia e della linguistica logico-matematica, che è associata ai cambiamenti fondamentali che la logica e la matematica hanno vissuto tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. Sotto l'influenza del successo dello sviluppo della linguistica, così come della logica simbolica e della matematica, viene rianimato l'interesse per i problemi della semasiologia, nel linguaggio scientifico, ei concetti logici stanno convergendo con le teorie psicologiche di parole, frasi e attività linguistica.
Direzione logica in linguistica
Linguistica filosofica nella prima metà del XIX secolo. sviluppato come confronto tra direzioni logiche e psicologiche. Entrambe queste direzioni hanno enfatizzato due aspetti dello studio della grammatica: formale e semantica; tuttavia, la comprensione della forma linguistica, e in particolare della semantica linguistica, era diversa.
La filosofia grammaticale di K. Becker "The Organism of Language" era l'applicazione della logica al materiale della lingua (tedesca) moderna. La lingua era intesa come un sistema di opposti organici, ad es. tali opposti, che non si distruggono a vicenda, ma, al contrario, si condizionano reciprocamente e sono necessari l'uno per l'altro nello sviluppo dell'organismo nel suo insieme. La dottrina della frase dalla logica e dalla stilistica è stata trasferita alla grammatica. La scuola logico-sintattica si è diffusa in diversi paesi. Rappresentanti di spicco di questa scuola in Russia erano N.I. Grek, P.M. Perevlessky, I.I Davydov.
Il più grande linguista russo, un rappresentante della direzione logica e grammaticale è F.I. Buslaev. Ha proceduto dall'unità di teoria e pratica, e il rapporto tra tradizioni filologiche e linguistiche è stata la questione centrale nello sviluppo dei fondamenti logici (filosofici), normativi (filologici) e storici della grammatica.
Il concetto linguistico dello scienziato è rivelato in una serie di suoi lavori: "Sull'insegnamento della lingua pubblica", "Esperienza della grammatica storica della lingua russa". Filologico il metodo di ricerca, secondo Buslaev, è finalizzato allo studio delle lingue morte e "per un filologo, la lingua è solo un mezzo per imparare la letteratura antica". Linguistico un modo per "comprendere" forme grammaticali dalle più diverse origini e composizioni. A differenza delle regole, che si basano sull'uso moderno del linguaggio del libro, “le leggi grammaticali si basano sulle proprietà della lingua, che sono costanti e non dipendono dall'uso temporaneo, limitato solo ad alcune forme.
Principio storicismo, secondo lo scienziato, collega entrambi i metodi di apprendimento delle lingue (filologico e linguistico) e stabilisce i confini esatti tra logica e grammatica, afferma la connessione tra linguaggio e pensiero. Buslaev credeva che la grammatica dovesse essere basata su principi logici, poiché nella sintassi dei linguaggi moderni "il significato astratto delle leggi logiche domina sulla forma etimologica e sulla rappresentazione visiva iniziale da essa espressa". La frase è al centro del concetto grammaticale di Buslaev. “... La sintassi è la base per l'intera costruzione del linguaggio, mentre l'etimologia adatta solo le parole con vari cambiamenti e forme. Poiché una parola fa parte di una frase, l'etimologia è inclusa nella sintassi come parte di essa. Le parti del discorso non sono altro che diverse forme di pensiero. Buslaev ha sviluppato e chiarito le disposizioni della scuola logico-semantica della direzione logica nella grammatica, creando la dottrina della base logico-formale della frase, la riduzione e la fusione delle frasi, la dottrina dei membri secondari della frase e delle clausole subordinate.
Concetto linguistico di A. Schleicher
A. Schleicher è il fondatore della direzione naturalistica in linguistica. Le sue opere principali: "Morfologia della lingua slava ecclesiastica", "Guida allo studio della lingua lituana", Sulla morfologia delle lingue ", sono dedicate alla classificazione morfologica delle lingue. Come Humboldt, Schleicher riteneva che lo studio della forma linguistica e la sistematica tipologica e genealogica delle lingue fossero il contenuto principale della linguistica, che studia l'origine e ulteriori sviluppi queste forme di linguaggio.
Schleicher ha chiamato la dottrina della morfologia dei tipi di linguaggio. Secondo Schleicher, la morfologia delle lingue dovrebbe studiare i tipi morfologici delle lingue, la loro origine e relazione reciproca... Sono consentiti tre tipi di combinazioni di significato e relazione: le lingue isolanti hanno solo significati (radici); le lingue agglutinanti esprimono significato e attitudine (radici e lingue); le lingue flessive formano un'unità in una parola che esprime significato e relazione.
I tipi morfologici del linguaggio, secondo Schleicher, sono una manifestazione di tre stadi di sviluppo: la classe monosillabica rappresenta la forma più antica, l'inizio dello sviluppo; l'agglutinazione è la fase intermedia dello sviluppo; le lingue flessive, come ultimo stadio, contengono in forma condensata gli elementi delle due precedenti fasi di sviluppo. La classificazione morfologica di Schleicher ha avuto una grande influenza sulla linguistica - nella direzione dello sviluppo della dottrina dei tipi di linguaggio. Considerando la relazione delle lingue indoeuropee come risultato dello sviluppo storico, Schleicher crea una teoria dell'albero genealogico delle lingue indoeuropee. Secondo la sua teoria, la proto-lingua indoeuropea nel periodo preistorico si è divisa in due gruppi di proto-lingue: nordeuropea (slavo-germanico) e sudeuropea (ario-greco-italiano-celtico). Nel periodo storico, la lingua greca antica ha mantenuto la vicinanza più vicina alla lingua indoeuropea, le più remote erano le proto-lingue germaniche e balto-slave. Considerava la lingua indoeuropea come un unico sistema di forme. Tuttavia, la proto-lingua non era una realtà storica per lui, ma l'idea del sistema audio e del sistema delle forme delle parole - solo un modello che è necessario per la considerazione dinamica del diverso materiale delle lingue indoeuropee.
Il compito degli studi comparativi, secondo Schleicher, è proprio quello di restaurare proforma sulla base dei resti superstiti della proto-lingua indoeuropea nelle antiche lingue indoeuropee.
A. Schleicher credeva che il linguaggio dovesse essere considerato come un organismo naturale che vive così come un organismo della natura. Il principio scientifico-naturale, su cui dovrebbe basarsi la linguistica, presuppone, a suo avviso, il riconoscimento dei seguenti postulati: 1) il linguaggio come organismo naturale esiste al di fuori della volontà dell'uomo, non può essere cambiato;
2) "La vita umana", come la vita della natura, è sviluppo, non storia;
3) la linguistica dovrebbe essere basata sull'osservazione accurata degli organismi e delle leggi della loro esistenza, sulla completa subordinazione del ricercatore all'oggetto della ricerca.
Avendo avanzato l'obbligo di tener conto delle leggi sane della lingua, Schleicher ha sviluppato un metodo per ricostruire la proto-lingua indoeuropea, interpretandola come un sistema di forme. Il nome di Schleicher è associato alla creazione di un albero genealogico delle lingue indoeuropee e allo sviluppo di una classificazione morfologica delle lingue.
Le basi filosofiche della linguistica comparativa - storica e tipologica furono poste da W. von Humboldt. Credeva che la linguistica dovesse avere una propria base filosofica: la filosofia del linguaggio, costruita su una solida base dell'analisi di diverse lingue. I principi di base della filosofia del linguaggio, secondo Humboldt, sono il riconoscimento del linguaggio e della sua forma come attività e coscienza nazionale delle persone. Humboldt ha sottolineato non solo il dinamismo del linguaggio, ma anche il suo attività. Il linguaggio è il risultato della sintesi creativa dell'attività mentale; è allo stesso tempo una forma attiva, uno strumento di questa attività mentale.
L'unità del linguaggio e del pensiero è un'unità dialettica indissolubile, questa è l'unità del pensiero e della parola, poiché il linguaggio come proprietà comune e collettiva influenza l'individuo, e come uomo migliore parla la lingua, più la lingua influenza il suo pensiero.
Humboldt ha sottolineato che "il linguaggio si sviluppa sempre in una comunità di persone, e una persona capisce se stessa solo assicurandosi che le sue parole siano comprensibili per un altro". Ma comprendeva la natura sociale del linguaggio come natura nazionale, come "ideale", che è "nella mente e nell'anima delle persone".
Inoltre, questo ideale non è universale (logico) e non individuale (mentale), ma a livello nazionale pensiero linguistico. Humboldt ha scritto: "La lingua del popolo è il suo spirito, e lo spirito del popolo è la sua lingua", "la lingua è collegata allo spirito nazionale con tutte le fibre più sottili delle sue radici, e più proporzionalmente quest'ultimo agisce sulla lingua, più naturale e ricco è il suo sviluppo". L'errore di Humboldt è stato quello di collegare la forma interna del linguaggio esclusivamente con lo spirito nazionale e l'idea assoluta, e questo errore è tipico della filosofia tedesca dell'idealismo oggettivo.
Lo studio della forma del linguaggio è la parte più importante della teoria linguistica di Humboldt. Ha sottolineato che sebbene il linguaggio sia associato alle attività delle persone e al loro pensiero, ha le sue specificità e relativa indipendenza e stabilità. L'attività linguistica e il linguaggio sono correlati, ma non identici. La lingua viene riprodotta in ogni momento, il discorso è vario. "La lingua è una forma e nient'altro che una forma", ha scritto Humboldt.
Poiché le forme della lingua sono uniche a livello nazionale, nella misura in cui il comune (universale) nelle lingue può essere trovato non mediante ragionamento logico, ma confrontando le forme delle lingue tra loro, utilizzando lingue correlate e non correlate, sviluppate e non sviluppate. Da un lato, Humboldt ha cercato di stabilire un legame genetico tra tutte le lingue: cinese e sanscrito, sanscrito e basco. D'altra parte, Humboldt ha messo a confronto le lingue che sono simili nella loro relazione ai tipi linguistici, creando una classificazione tipologica delle lingue. I tipi di linguaggio sono determinati non dalla generalità degli elementi materiali, ma dalla loro struttura. Il tipo di linguaggio secondo Humboldt viene stabilito scoprendo il comune nella struttura delle sue parole e frasi. Esistono quattro tipi principali di linguaggi: radice, agglutinante, polisentetico e flessivo. Il concetto linguistico di Humboldt ha avuto un enorme impatto sullo sviluppo della teoria linguistica. Si trova nelle teorie di G. Steinthal e A. Potebnya, I. A. Baudouin de Courtenay e F. de Saussure, E. Sapir e N. Chomsky, e N. Meshchaninov e D. Greenberg. Il significato delle opere di Humboldt sta nel fatto che egli ha dimostrato che la linguistica dovrebbe avere la sua "filosofia" - una teoria linguistica basata sulla generalizzazione di tutto il materiale fattuale delle lingue - relativa e non correlata, grande e piccola.
Comunità sociali e tipi sociali di lingue
Il funzionamento e lo sviluppo della lingua è associato alla storia della società, alle comunità sociali delle persone. Queste comunità sono caratterizzate da tipi sociali di lingue, poiché ogni comunità sociale è caratterizzata da una caratteristica linguistica e l'esistenza e il funzionamento di una lingua sono determinati dalla comunità sociale delle persone. Le principali forme conosciute di comunità di persone sono il gruppo etnico, la nazionalità, la nazione e la comunità interetnica di persone. In quanto formazioni storiche, le loro lingue in condizioni moderne mantengono la specificità della loro natura sociale, funzionamento e struttura. I tipi sociali più moderni sono la lingua della nazionalità e la lingua nazionale.
Nazionalità derivano dalle tribù e dalle loro alleanze. La base economica per l'emergere di una nazionalità sono i rapporti di produzione precapitalisti. Una lingua comune e un territorio comune, l'unità della struttura spirituale e della cultura sono le caratteristiche principali di una nazionalità.
La lingua di una nazione, che è la sua caratteristica più importante, è caratterizzata da una struttura funzionale e stilistica asimmetrica: a una lingua comune, che si manifesta come centro economico e politico di primo piano o sotto forma di lingua letteraria e scritta, si contrappongono i dialetti locali (territoriali). Lingua e dialetto differiscono in quanto la lingua serve l'intero comunità etnica, e quindi è una formazione multifunzionale e strutturalmente indipendente, e la sua struttura dipende dal linguaggio di cui è una variante. La lingua di una nazionalità può avere una forma scritta letteraria. Tuttavia, il significato unificante della lingua letteraria scritta rimane insignificante, il che si manifesta nella sua bassa funzionalità, prevalenza e autorità. Questo spiega l'uso di una lingua non nativa nella funzione della lingua letteraria scritta. Tuttavia, le prime lingue letterarie hanno svolto un ruolo importante nello sviluppo delle lingue letterarie moderne. Le nazioni nascono, esistono e si sviluppano solo in presenza di legami economici un largo numero persone legate da un territorio comune, la lingua dell'identità nazionale, manifestata nell'unità della cultura e nella composizione spirituale delle persone. L'unità della lingua e il suo sviluppo senza ostacoli è una delle caratteristiche principali di una nazione. La lingua nazionale, a differenza della lingua della nazionalità, ha necessariamente una forma letteraria - scritta; la propagazione e il rafforzamento della norma comune è la preoccupazione speciale della nazione.
La sensazione della lingua madre come caratteristica etnica è preservata dal fatto che in questa lingua esiste una letteratura che esprime il sentimento nazionale e l'identità nazionale. La lingua nazionale è una forma di cultura nazionale. Il collegamento tra lingua e nazione - in particolare - storico e modi di formazione delle lingue nazionali, il loro stile funzionale e la struttura dei livelli sono diversi. Ogni nazione ha la sua lingua, ma questo non significa che la lingua di una nazione sia sempre primordiale: la sua e tutte le nazioni si riferiscono alla loro lingua allo stesso modo. La lingua nazionale nasce sulla base della lingua della nazionalità e quindi non è solo sua, ma anche singolare, unica.
La lingua come norma socio-storica
La norma linguistica nelle teorie moderne deriva dal confronto con il sistema linguistico. Il sistema linguistico è inteso come il potenziale strutturale della lingua e il suo schema astratto, la norma del linguaggio, rispettivamente - come la realizzazione della possibilità di questo schema strutturale in calcestruzzo - forma storica questa o quella lingua.
La norma linguistica come fenomeno storico concreto è caratterizzata da almeno tre proprietà: selettività, conformità e obbligo. Selettività le norme linguistiche si manifestano nel fatto che ogni norma linguistica implementa il sistema linguistico a modo suo e si risolve in modo diverso attività cognitiva delle persone. La selettività rende la norma linguistica un fenomeno complesso, contraddittorio e dinamico. Allo stesso tempo, la norma linguistica è sostenibile formazione scolastica. La sua stabilità risiede principalmente nel fatto che la norma si manifesta nella coscienza e nella pratica di tutti i membri di una data comunità linguistica come qualcosa in comune; passando di generazione in generazione, unisce l'attività linguistica dei parlanti, separati da tempo, luogo, status sociale, livello di conoscenza e sviluppo spirituale. La sostenibilità si manifesta come la conservazione delle tradizioni linguistiche, il graduale sviluppo della cultura della lingua. Obbligola norma linguistica deriva non dalle manifestazioni interne del sistema linguistico, ma da requisiti esterni per esso: l'accettazione di alcuni fatti della lingua. Tutto ciò che viene riconosciuto dalla società è considerato non solo obbligatorio, ma anche corretto. Norma linguistica È un insieme degli elementi più stabili e tradizionali del sistema linguistico, storicamente selezionati e consolidati dalla pratica linguistica pubblica.
Linguaggio e pensiero, parola e pensiero sono così collegati tra loro che molti linguisti e filosofi ritengono possibile parlare del pensiero linguistico come un fenomeno sincretico, e il contesto e la situazione del discorso sono identificati con l'esperienza di una persona o della società.
Fino ad oggi, il tema del rapporto tra linguaggio e pensiero è il più incomprensibile e altrettanto attraente per studiare dal lato della linguistica, psicologia, linguistica, psicolinguistica, logica e altre scienze. Anche senza conoscere i segni con cui il pensiero svolge il suo lavoro, e solo indovinando approssimativamente come si svolge la nostra attività linguistica, non abbiamo dubbi che pensiero e linguaggio siano interconnessi. Quante volte nella vita ognuno di noi ha avuto l'opportunità di comunicare alcune informazioni a qualcuno. In questo caso, il processo di conversazione mira a generare un processo di comprensione per il destinatario delle informazioni. Ma ci sono casi in cui usiamo il linguaggio non per trasmettere informazioni ad altre persone, ma per organizzare il nostro processo di pensiero: silenziosamente, in un sussurro o "a noi stessi", pronunciamo parole, e talvolta intere frasi, cercando di capire o capire qualcosa. E che risultato straordinario! Spesso, un pensiero rivestito di parole, per così dire, si materializza nella nostra mente e diventa chiaro e comprensibile.
La teoria dei significati linguistici, la connessione tra linguaggio e pensiero sono aspetto critico linguistica, costituiscono un'area speciale della conoscenza linguistica. La sezione di linguistica generale che studia la relazione tra linguaggio e pensiero può essere chiamata metalinguistica.
Che la struttura di una lingua unisca unità di varie strutture e scopi è noto da tempo. In pratica, i linguisti hanno sempre distinto fonetica e grammatica, parola e frase; parti del discorso sono state considerate come categorie lessicali e grammaticali che uniscono unità della struttura della lingua.
All'inizio del XIX secolo, specialmente nelle opere di W. Humboldt, si distinguevano due tipi di unità linguistiche: il materiale, che forma la forma esterna della lingua, e l'ideale, che forma la forma interna della lingua; l'unità delle forme esterne e interne ed è stata intesa come la struttura del linguaggio. Allo stesso tempo, lo studio delle specificità delle unità linguistiche: parole e frasi, categoria grammaticale e morfemi. Nella prima metà del XX secolo, i rappresentanti del Circolo linguistico di Praga hanno identificato due unità elementari di analisi linguistica: una caratteristica differenziale e questa. Analizzando le unità linguistiche e sviluppando un metodo di analisi linguistica, si è riscontrato che il lato ideale è molto più complicato del lato materiale delle unità linguistiche e delle loro categorie.
In linguistica si sono diffusi due tipi di teorie: sostanziali e operative. Teorie sostanziali tentano di risolvere il problema della struttura del linguaggio, procedendo dalla funzione comunicativa della lingua, portando in primo piano le classi lessicali e grammaticali.
Le teorie operative (metodiche) cercano di risolvere il problema della struttura del linguaggio, evidenziando la funzione strutturale della lingua, nonché l'isomorfismo e la gerarchia dei lati delle unità linguistiche.
La teoria dell'isomorfismo considera l'integrità della struttura del linguaggio a livello della metodologia descrittiva, basata sui risultati della fonologia moderna. Le unità reali del linguaggio sono sostituite dalle unità di descrizione, la natura complessa del lato ideale viene ignorata. La ricerca di universali metodologici oscura l'unicità qualitativa dei livelli della lingua e dei diversi lati dell'unità linguistica. L'idea di isomorfismo non spiega la complessità della struttura linguistica come sistema di un tipo speciale; lo riduce alle strutture più semplici con una struttura planare.
La teoria della gerarchia dei livelli è una teoria operativa che si basa sull'idea di una struttura gerarchica simultanea della struttura del linguaggio. Fu formulato più chiaramente nel 1962 da E. Benveniste. Si parte dal presupposto che le unità linguistiche si basano su un livello basso dal piano di espressione e dal piano di contenuto entrano nel livello superiore, la struttura della lingua è rappresentata come segue:
Un livello è un operatore: fonemi, morfemi, elementi verbali dei livelli principali che compongono la struttura della lingua. Se un fonema è definibile, allora solo come parte costituente di un'unità di livello superiore - un morfema. L'unica differenza tra un morfema e una parola è che un morfema è un segno di una forma legata e una parola è un segno di una forma libera. Esistono relazioni distributive tra fonemi, morfemi e parole come elementi dei loro livelli e relazioni integrative tra diversi livelli. Ciò dà origine a due funzioni: costitutiva e integrativa, creando la forma e il contenuto dell'unità. La forma di un'unità linguistica è la sua capacità di decomporsi in elementi costitutivi di livello inferiore e il suo significato è la capacità di essere parte integrante di un'unità di livello superiore. Una tale comprensione della struttura linguistica consente solo una direzione di analisi: dal livello più basso al più alto, dalle forme al contenuto. Il problema dell'interazione dei livelli è relegato in secondo piano e al concetto stesso di livello viene attribuito un significato operazionalistico. Il morfema è considerato il segno principale della lingua, grazie al quale è riconosciuto come il suo livello più basso e la parola come il più alto.
La lingua è prevalentemente un sistema di parole collegate tra loro e strutturalmente organizzate. Categorie di parole lessico-semantiche e lessico-grammaticali, con le quali le regole di formazione e inflessione delle parole sono direttamente correlate, formule per la costruzione di frasi e frasi, sistemi di paradigmi e campi: questo è ciò che forma il sistema dei sistemi linguistici e le regole per la scelta e l'uso delle parole implementano il sistema linguistico nell'attività vocale degli oratori ...
La parola come unità strutturale di base ha una struttura a più livelli. La connessione tra unità e categorie di tutti i livelli viene effettuata attraverso la parola come un'unità appartenente all'una o all'altra parte del discorso.
Nella storia della linguistica, il problema delle parti del discorso ha sempre occupato un posto centrale. Scienziati di diverse direzioni e scuole lo hanno risolto in modo ambiguo, ma tutti hanno cercato di legare le parti del discorso principalmente a un livello del linguaggio e spiegarlo con i tipi di riflessione nel linguaggio delle categorie di pensiero. Le teorie che classificano parti del discorso come classi di parole morfologiche o sintattiche sono molto comuni: i tentativi di associare parti del discorso con la fonetica e la morfemia di una parola sono meno comuni.
Ogni parola appartiene all'una o all'altra parte del discorso, indipendentemente dal fatto che si riferisca alle unità nucleari o periferiche di questa parte del discorso. La parola rappresenta potenzialmente una parte del discorso, esprimendo le sue proprietà a vari livelli. Quindi, la parola collega un lessema specifico con le caratteristiche della struttura della lingua; unisce i lati materiali e ideali dei linguaggi dei segni, dei semisegni e dei segnali. La parola è caratterizzata da diversi tipi di significati e ogni tipo nel numero schiacciante di parole è rappresentato non da uno, ma da diversi significati. Quindi la parola è caratterizzata da significati: lessicale, morfologico, derivazionale e sintattico. Collegando questi significati in un'unità, la parola unisce tutti i livelli della lingua.
Caratteristiche dei livelli intermedi
I livelli intermedi sono: morfologico, derivazionale, fraseologico.
Livello morfonologico si verifica all'incrocio di fonemi e morfemi. Anche i rappresentanti della scuola linguistica kazana hanno richiamato l'attenzione sulla necessità di distinguere tra cambiamenti fonetici e alternanze, sulla connessione tra fonemi e morfemi della lingua.
La morfologia studia l'alternanza di vocali e consonanti, così come lo stress e le combinazioni di fonemi in morfemi e parole. Quindi, l'alternanza dei fonemi (k / h) nelle parole fiume-fiume non è associata a cambiamenti fonetici, ma è dovuta all'unità del morfema. Allo stesso tempo, la differenza fonologica aiuta a identificare le varianti del morfema, della forma della parola e del lessema [move - (it) - walk - (ba) - walk - (en)].
Lo stress può svolgere anche una funzione morfologica. Quindi, nella lingua russa, lo stress caratterizza le varietà di paradigmi nominali e verbali, distingue tra forme verbali e parole (blocco - blocco).
Originalità formazione di parole come livello intermedio della lingua consiste nel fatto che i morfemi e le loro categorie (basi di produzione, modelli di formazione di parole), basi di riproduzione, modelli di formazione di parole), riproducendo morfemi e categorie morfologiche, generano unità linguistiche nominative - parole che hanno un significato lessicale, indipendentemente dal fatto che siano conservate se sono come unità motivate in modo formato dalla parola o stanno perdendo questa motivazione. Inoltre, la formazione delle parole e i significati lessicali della parola non coincidono. Le unità nominative della lingua sorgono non solo in un modo formativo-morfologico delle parole, ma anche sulla base di esse - cambiando il significato lessicale e padroneggiando i lessemi presi in prestito, ad esempio, come risultato dell'integrazione di due o più lessemi (il primo pancake è grumoso, affina le frange, il Mar Nero). Sebbene tali unità siano costruite secondo i modelli di frasi e conservino formalità separate, sono riprodotte come un'unità nominativa singola. Tra le unità nominative analitiche si distinguono prima di tutto le unità fraseologiche (unità fraseologiche, idiomi, frasi stabili) e i nomi dei composti.
Unità fraseologiche ei termini composti, non essendo un tipo speciale di unità, formano un livello linguistico intermedio tra i lessemi, formano un livello linguistico intermedio tra i lessemi e le loro combinazioni. Sorgendo sulla base di una frase, le unità fraseologiche ei termini composti si riferiscono alla sintagmatica e alla sintassi, ma secondo le condizioni di funzionamento come unità nominative, possono essere classificate come una sorta di strato del sistema lessicale-semantico della lingua.
Livello fonetico-fonologico studia la struttura sonora della lingua, che consiste in suoni vocali, le regole per combinarli nel flusso vocale e nelle categorie fonetiche. I suoni del parlato sono caratterizzati da proprietà articolatorie, acustiche e fonologiche.
Le caratteristiche di articolazione dei suoni del linguaggio collegano la struttura sonora della lingua con le capacità fisiologiche e le abilità di chi parla e, di conseguenza, con la società, poiché la base di articolazione della lingua è un fenomeno socio-psicologico. Il sistema audio della lingua ha due categorie principali: vocali si consonanti. Differiscono tra loro per articolazione, struttura e ruolo-funzione nella formazione di una sillaba e morfema; le vocali sono suoni sillabici, le consonanti svolgono solo la funzione di distinzione dei morfemi. I fonemi come segnali linguistici distinguono tra morfemi e parole, hanno un'organizzazione interna che ne garantisce le prestazioni e l'utilizzo nel flusso vocale. Esistono due tipi di organizzazione dei suoni linguistici:
a) opposizioni fonologiche e classi distributive di fonemi;
b) cambiamenti di posizione dei suoni, la loro struttura di sillabe.
I cambiamenti nei suoni nel flusso della parola si riflettevano nella dottrina dei cambiamenti combinatori e posizionali, nella fonetica della fine e dell'inizio di una parola, nei fenomeni fonetici all'incrocio dei morfemi, così come nella segmentazione e classificazione dei fonemi proposti dai fonemi descrittivi.
Strato morfologico la lingua copre due tipi di unità: morfema e forma di parola. Se un morfema è la più piccola unità significativa di una lingua, allora i morfemi non sono solo affissi e radici, ma anche parole di servizio. Considerando il morfema come un'unità a due lati, ad es. come segno strutturale, in esso si distinguono il materiale e le parti ideali. Il lato materiale è varianti fonetiche. Ad esempio, nelle parole acqua, zia, giovane, papà, i suoni [a], ["^], [a], [a] sono varianti fonetiche dello stesso morfema. D'altra parte, ogni morfema e ciascuna delle sue varianti ha una serie di grammatiche Quindi, l'inflessione -а (nella parola acqua) ha tre significati (semes): f.r., singular, im.p., cioè il lato ideale è semes (significati). I morfemi sono suddivisi in due classe: morfemi significativi (radici) e servizio (affissi).
Il concetto di forma verbale è stato introdotto nella teoria morfologica dai rappresentanti della scuola linguistica di Mosca. Wordform è l'unità più importante della struttura morfologica dei linguaggi flessivi e agglutinanti, ad es. lingue che hanno affissi. Wordform - questa è l'articolazione primaria della parola, la disintegrazione della parola in una parte costante - la base e l'inflessione variabile. La radice esprime significati grammaticali lessicali e generali, la desinenza - significati grammaticali particolari. Ad esempio, le forme delle parole mi siedo, il vaso si disintegrano nelle basi di sij- e vaz- e inflessione -u e -y; la radice verbale esprime il significato del tempo presente, quello nominale - il significato di oggettività, l'inflessione -y - il significato di 1 persona, singolare, l'inflessione -y - il significato di vin.p., singolare.
La seconda divisione di una parola è l'allocazione di una radice generatrice e di un affisso di formazione di parole in essa. Ad esempio, nelle parole candy bowl e retell, vengono evidenziate le basi di sweets e skaz-, da cui sono state formate aggiungendo il suffisso -nits- e il prefisso pere-. Blocchi di morfemi che formano gambi derivati \u200b\u200be affissi complessi sono la stessa realtà del livello morfemomorfologico, così come lo sono i morfemi stessi, da cui sono nati diacronicamente e storicamente.
Livello sintattico la lingua, come la morfologica, ha unità di due tipi: una frase e una frase. Esiste una certa relazione tra di loro: le frasi, come le forme delle parole, sono materiale costruttivo per costruire frasi basate sui propri campioni. Sia la struttura morfologica della parola che la divisione del modello della frase in frasi utilizzate nella frase non sono identiche alla struttura sintattica della frase: la frase è divisa non solo in frasi, ma anche nei membri della frase e nel sintagma.
Una combinazione di parole come modello sintattico consiste nella forma di una parola, combinata sulla base del collegamento sintattico e del significato sintattico. Quindi, la frase parola dell'insegnante è una combinazione dei casi nominativo e genitivo del sostantivo, che sono in una relazione subordinata di controllo ed esprimono relazioni attribino-soggetto: se il caso nominativo “controlla” la forma di connessione, allora il sostantivo nel caso genitivo “controlla” la semantica della relazione.